Siamo nell’agosto 2011, e il general Formigoni parla della crisi, dei tagli governativi, che porteranno a gravi sacrifici, eccetera. E lo fa davanti alla nuova sede della Regione Lombardia, un complesso di grattacieli che è costata una fortuna: era il caso di spendere tutti quei soldi? La crisi dura da parecchi anni, il debito pubblico e il deficit di bilancio non sono certo una novità (ce li portiamo dietro dall’era di Craxi e di Andreotti): e se Formigoni tutti quei soldi non li avesse spesi, se si fosse tenuto la sede vecchia, quanti ticket sanitari in meno, quanti soldi in più per la scuola pubblica? Questi conti non li farà mai nessuno, si dirà che sono tutti soldi dei privati (si dice sempre così), e quindi mi fermo con le domande. Anzi, no, ne faccio un’altra, una soltanto: cos’aveva il Pirellone di sbagliato, perché non andava più bene come sede della Regione Lombardia?
A me è sempre piaciuto, il Grattacielo Pirelli: di solito non amo i grattacieli, ma questo qui ha delle belle forme, un aspetto gentile. Non so come ci si viva dentro, ma da visitatore o da passante tutto pare che abbia un senso, in questa costruzione, e che tutto sia stato pensato per viverci e non solo per guardarlo dal di fuori.
Gran parte del merito penso che vada ai suoi progettisti, soprattutto al più famoso, il milanese Giovanni Ponti (in arte Giò Ponti) che non fu “soltanto” un architetto ma che lavorò in molti altri settori: da non perdere i suoi lavori come ceramista per la ditta Richard Ginori. Insomma, il Grattacielo ex Pirelli è il classico caso in cui si vede una persona dietro l’opera: non un io narcisistico e strabordante, ma qualcuno in grado di armonizzare le proprie idee e i propri progetti con l’ambiente circostante, senza essere invasivo, senza volersi imporre.
Dall’alto del Pirellone, oggi, si guarda giù e si vede il Centro Commerciale – pardon, la Stazione Centrale, e la Piazza della Stazione recentemente resa in stile metafisico-razionalista-futurista, tutta marmo e cemento. Monumenti allo spreco, a Milano, ne sono sorti tanti; ma la nuova sede della Regione Lombardia, e il restyling delle piazze, e del metrò, penso che siano i monumenti allo spreco per eccellenza. Ne pagheremo le conseguenze per almeno vent’anni, questo è solo l’inizio; e tremo di raccapriccio al pensiero del giorno in cui si scoprirà come sono davvero i conti della Regione Lombardia. E mi dispiace che i nati nel nuovo millennio possano pensare che è stato sempre così: Milano non è mai stata una città bella come Venezia o Firenze, ma era una città vivibile, una delle capitali europee in tutti i sensi. Così l’ho trovata io, e così è stata fino a una quindicina di anni fa: a Milano c’era gente che si dava da fare ma senza volersi imporre, e basterà qui fare l’esempio del Piccolo Teatro, che era davvero una piccola sala, piccola e scomoda, ma che era guidato da persone capaci di diventare un punto di riferimento per tutta l’Europa. La stessa cosa succedeva un po’ dappertutto, anche nell’industria e nell’economia, a Milano: si trattava quasi sempre di persone discrete, magari di pessimo carattere e con molti difetti, ma che sapevano quasi sempre lavorare per il bene comune e non solo per il proprio. Le cose sono peggiorate lentamente, a partire da metà degli anni ’60, con il dilagare della mafia e della corruzione (si pensi a Sindona, e a tutto quel che è seguito). Ma, per non allargare troppo il discorso e per fermarsi al Grattacielo qui davanti, mi viene da pensare che sono i dittatori o i maleducati o i narcisisti quelli che vogliono lasciare in modo vistoso e prepotente la loro firma,: fate voi, chi di questi tre ci è toccato in sorte negli ultimi 10-15 anni? Secondo me, un po’ tutti e tre i tipi; e non è un caso che siano tornati di moda, piuttosto che Giò Ponti o Bruno Munari, nomi come quelli di Terragni, di Marinetti, eccetera. Brutti tempi, Marinetti fece l’elogio della guerra (zzang-tumb-tumb è il suono delle bombe e delle pallottole: a lui piaceva, pensa un po’), oggi speriamo di cavarcela, e speriamo che questa spaventosa slavina di asfalto e di cemento quantomeno si fermi. Ma ne dubito, ormai il danno è stato fatto, ormai le nuove generazioni pensano che il mondo sia questo, che la modernità sia il grigiore universale. Non credo che riuscirò mai ad abituarmi.
da www.wikipedia.it
Il Grattacielo Pirelli o Palazzo Pirelli, chiamato comunemente “Pirellone”, è l'edificio di Milano ove ha sede il Consiglio regionale della Lombardia. Si innalza all'angolo sud-ovest di piazza Duca d'Aosta, dove si trova anche la Stazione Centrale. Il Grattacielo Pirelli fu progettato nel 1950 e incluso nel nascente "Centro Direzionale". Fu costruito tra il 1956 e il 1961 su progetto di Gio Ponti, Giuseppe Valtolina, Pier Luigi Nervi, Antonio Fornaroli, Alberto Rosselli, Giuseppe Rinardi e Egidio Dell'Orto; Gio Ponti diresse anche tutte le fasi costruttive. L'aspetto strutturale venne curato da Giuseppe Valtolina, in collaborazione con i consulenti Pier Luigi Nervi, Arturo Danusso, Piero Locatelli e Guglielmo Meardi. La realizzazione venne affidata all'impresa della Bonomi in collaborazione con Comolli e Silce. È un'opera architettonica importante, propria del razionalismo italiano; con i suoi 127 metri di altezza, distribuiti su 31 piani (altri 2 piani sono sotterranei) è uno degli edifici in calcestruzzo armato più alti al mondo. Originariamente il palazzo fu costruito per ospitare gli uffici della celebre azienda italiana di pneumatici Pirelli: nell'area su cui sorge esistevano degli stabilimenti del gruppo, distrutti dai bombardamenti aerei durante la seconda guerra mondiale. (...) La tradizione vuole che nessun edificio a Milano possa essere più alto della Madonnina del Duomo, tradizione che divenne negli anni trenta anche legge comunale, salvo deroghe. Quando fu realizzato l'edificio e quindi violata la tradizione, si decise di porvi in sommità, in segno di rispetto, una piccola replica della statua che sovrasta i marmi di Candoglia del Duomo. Dietro la tradizione ci sono tuttavia problemi tecnici e strutturali: pochi metri sotto la superficie della città c'è la falda freatica ed inoltre, poiché anticamente la pianura Padana era un mare, è assente una base rocciosa in profondità. Nel 1978 il grattacielo venne acquistato dalla Regione Lombardia, per farne la propria sede principale dopo una ristrutturazione ad opera dell'architetto Bob Noorda. (...) L'ingresso che per molto tempo è rimasto l'accesso principale, si trova in piazza Duca d'Aosta: è rialzato rispetto al piano della piazza tramite una struttura detta "collina", che contiene al suo interno uno spazio adibito ad auditorium. Oggi si accede alla sede della Regione dal retro dell'edificio. (...) Il 18 aprile 2002 un aereo da turismo pilotato dall'italo-svizzero Luigi Fasulo, 64 anni, si schiantò contro il 26º piano del palazzo, danneggiando gravemente la struttura esterna e sventrando due piani. La collisione causò tre vittime: il pilota e due donne, dipendenti della Regione Lombardia. Oggi il 26º piano ospita il "Luogo della memoria" dedicato alle due donne morte, Anna Maria Rapetti e Alessandra Santonocito (...) da fine maggio 2005 è tornato ad ospitare il Consiglio regionale della Lombardia. La Giunta regionale invece si è trasferita nel 2011 a Palazzo Lombardia.
venerdì 30 marzo 2012
mercoledì 28 marzo 2012
Milano, l'arengario
Le prime volte che venivo a Milano, devo ammetterlo, che ci fosse un Arengario mi era proprio sfuggito. C’erano tante cose da vedere, in Piazza del Duomo: i piccioni per esempio (a me piacciono molto i piccioni, e anche le tortore, e anche i bambini e i turisti che si fanno fotografare coi piccioni), ma anche il cavallo del monumento, il leone, tante cose. Dell’Arengario (che non sapevo ancora che si chiamasse così) più che altro mi aveva colpito il grande terrazzo, e ci ero andato sopra con una ragazza (a dire il vero, mi ci aveva portato lei: sono sempre le ragazze che insistono per andare in alto, sulle terrazze, sulle guglie del Duomo, nei piani alti del caffè in Galleria...). Avrei capito solo in seguito che cos’era, da dove veniva, e già mi era poco simpatico all’inizio, figuriamoci dopo. Ma, in fin dei conti, non è mica colpa sua, se è così brutto: casomai di chi l'ha progettato e costruito.
Comunque sia, il mio parere è esattamente questo:
- Torniamo a Milano. Il Museo del Novecento non le è piaciuto.
«No. A mio avviso l'errore principale sta nel rapporto tra contenitore e contenuto. Credo che sia mancata un'analisi di cos'era l’Arengario, del perché era stato costruito: un luogo, cioè, da cui Mussolini poteva arringare le folle. Dall'assenza di un brivido di orrore penso nasca la mancata riuscita dell'impresa. Anche i tempi veloci di messa in opera non li considero un fatto positivo. Si è avuta l'impressione che la volontà politica di arrivare a un'inaugurazione in tempo per le scadenze elettorali abbia avuto la meglio su rigore e pensiero. Speriamo che si proceda a dei correttivi. Ma i Morandi e i De Chirico sui pianerottoli, tra scale mobili e segnali acustici degli ascensori, come dentro una Fnac o un Coin, temo resteranno».
- E il Quarto Stato di Pelizza da Volpedo sulla rampa d'ingresso?
«La collocazione odierna penalizza moltissimo il dipinto. Sembra un grande poster».
(Giovanni Agosti, storico e critico d’arte, dal Venerdì di Repubblica 7 ottobre 2011)
Non so bene chi sia Giovanni Agosti e non lo conosco di persona, ma in quest’occasione ha espresso benissimo anche il mio pensiero in proposito, e per questo lo ringrazio.
Ma poi che cos’è, di preciso, un arengario? Questa è la definizione secondo la Garzantina: «Arengario: in epoca comunale, il luogo dell’assemblea popolare, poi l’assemblea stessa, e infine l’edificio o il pulpito da cui si “arringava” il popolo.» «Arengo: nei comuni medievali, assemblea di tutta la cittadinanza (parlamento). Pur convocato raramente, aveva ampi poteri deliberativi.»
Un Arengario è quindi una costruzione medievale, dell’epoca dei Comuni; l’origine del nome è la stessa di “arringare”, l’arringa dell’avvocato, arringare la folla, queste cose qui. Essendo una costruzione che risale agli anni ’20 del Novecento, l’arengario di Milano è quindi un arengario solo per modo di dire, non autentico. Invece a Monza, per chi volesse farci un giro, c’è un Arengario vero: medievale, e non farlocco come questo di Milano
(la foto dell’Arengario è mia, è la stessa dell’altro giorno per Palazzo Reale, qui non si butta via niente e non si spreca niente.)
Comunque sia, il mio parere è esattamente questo:
- Torniamo a Milano. Il Museo del Novecento non le è piaciuto.
«No. A mio avviso l'errore principale sta nel rapporto tra contenitore e contenuto. Credo che sia mancata un'analisi di cos'era l’Arengario, del perché era stato costruito: un luogo, cioè, da cui Mussolini poteva arringare le folle. Dall'assenza di un brivido di orrore penso nasca la mancata riuscita dell'impresa. Anche i tempi veloci di messa in opera non li considero un fatto positivo. Si è avuta l'impressione che la volontà politica di arrivare a un'inaugurazione in tempo per le scadenze elettorali abbia avuto la meglio su rigore e pensiero. Speriamo che si proceda a dei correttivi. Ma i Morandi e i De Chirico sui pianerottoli, tra scale mobili e segnali acustici degli ascensori, come dentro una Fnac o un Coin, temo resteranno».
- E il Quarto Stato di Pelizza da Volpedo sulla rampa d'ingresso?
«La collocazione odierna penalizza moltissimo il dipinto. Sembra un grande poster».
(Giovanni Agosti, storico e critico d’arte, dal Venerdì di Repubblica 7 ottobre 2011)
Non so bene chi sia Giovanni Agosti e non lo conosco di persona, ma in quest’occasione ha espresso benissimo anche il mio pensiero in proposito, e per questo lo ringrazio.
Ma poi che cos’è, di preciso, un arengario? Questa è la definizione secondo la Garzantina: «Arengario: in epoca comunale, il luogo dell’assemblea popolare, poi l’assemblea stessa, e infine l’edificio o il pulpito da cui si “arringava” il popolo.» «Arengo: nei comuni medievali, assemblea di tutta la cittadinanza (parlamento). Pur convocato raramente, aveva ampi poteri deliberativi.»
Un Arengario è quindi una costruzione medievale, dell’epoca dei Comuni; l’origine del nome è la stessa di “arringare”, l’arringa dell’avvocato, arringare la folla, queste cose qui. Essendo una costruzione che risale agli anni ’20 del Novecento, l’arengario di Milano è quindi un arengario solo per modo di dire, non autentico. Invece a Monza, per chi volesse farci un giro, c’è un Arengario vero: medievale, e non farlocco come questo di Milano
(la foto dell’Arengario è mia, è la stessa dell’altro giorno per Palazzo Reale, qui non si butta via niente e non si spreca niente.)
lunedì 26 marzo 2012
Metropolitana ( II )
I posti come la metropolitana, gli aeroporti, le stazioni, le sale d’attesa in generale sono stati studiati in un bel libro dell’antropologo Marc Augé, che li ha chiamati “non-luoghi”. I non-luoghi sono i luoghi dove si è soli pur essendo in tanti, con “l’individuo sempre più omologato ma paradossalmente sempre più convinto di emergere dal gruppo”. «...ad esempio, si può accedere all’anonimato dei non-luoghi solo dopo aver dato prova della propria identità, mostrato passaporto, biglietto di viaggio, carta di credito (...)» (Marc Augé, citato sul Corriere della sera il 15.11.1993)
Il libro è Marc Augé, “Non luoghi – Introduzione ad un’antropologia della surmodernità”, editore Eleuthera, pag. 111, lire sedicimila: il fatto che il prezzo sia ancora in lire è dovuto al fatto che si tratta di un mio appunto ormai quasi ventennale, e direi che rende bene l’idea del tempo che è passato, per l’appunto quasi vent’anni.
Nel frattempo, che cosa è successo? E’ successo questo, che qualcuno ha pensato di intervenire sui “non-luoghi” cercando di renderli un po’ meno anonimi, un po’ meno impersonali; ed è stato un gravissimo errore, perché non è detto che i non-luoghi siano di per sè cose brutte. L’importante è la pulizia, in primo luogo; che ci si possa sedere, per esempio. E poi la sicurezza, certamente; ma senza esagerare, come purtroppo è successo e succede (anche con casi gravi, purtroppo, sia come invasione della nostra privacy che per cose peggiori). Ma riempire ogni spazio con musica e pubblicità, come si è fatto di recente, è davvero un rimedio peggiore del male: innanzitutto, perché non si deve imporre di ascoltare qualcosa a chi non è interessato ad ascoltarla. A casa mia, se arriva qualcuno spengo la tv o abbasso il volume della musica che sto ascoltando: al limite chiedo se piace, magari accendo il registratore, evito comunque di imporre agli altri qualcosa che gli altri non hanno voglia di ascoltare. Mi sembra il livello minimo della decenza, e della buona educazione.
Invece, non è andata così; per consolarmi, metto qui sotto un altro brano che parla della metropolitana, sperando che siano in arrivo tempi migliori. Si tratta di un grandissimo artista, è un brano a cui sono molto affezionato, e sono contento di poterlo rimettere in circolazione.
«Ho un figlio. E’ un bambino ritardato, vive in una casa di cura con altri diciotto bambini. Io me ne occupo molto e lui mi dà molto, richiede attenzioni e amore, io gliene dò e questo mi permette di restare un bambino, di esprimermi in modo semplice e chiaro. Non parlo di solito di questo, non c’è niente da dire e non c’è niente da nascondere, è la vita. Gli ho telefonato ieri, e mi ha chiesto se a New York avevo preso la metropolitana, se era silenziosa come quella di Parigi, se era pulito; e io gli risposto “no, ci sono i graffiti ed è molto rumoroso”. E lui ha concluso che era la stessa cosa. Gli ho detto: “spero di tornare a New York per portarti a vedere l’esposizione”. Mi ha chiesto: “Che cosa c’è nel museo?” e io gli ho detto: “Un tempio egizio, i giardini cinesi, i battelli africani”; e lui mi ha risposto che preferiva il metrò. Allora verrò a New York il mese prossimo per mostrare il metrò a mio figlio. Lo amo molto, lui ama guardare la vita e io non potrei vederla senza di lui.» (Jean Michel Folon, intervista con Luciana Capetti da L’Europeo 21 aprile 1990)
I gestori odierni della Metropolitana, oltre ai restyling chiassosi (da locale disco o da videogame) ci hanno regalato autentiche finezze burocratiche: ai tornelli non basta più obliterare, adesso devi indovinare dove devi obliterare (siamo dunque all’arzigogolo, ma temo che non sia ancora finita). I passeggeri abituali – mi sembra quasi inutile dirlo ma non si sa mai - lo sanno da per loro (milanesismo dialettale), così come sanno schivare i pilastri, e sanno dove scendere fino ai binari e che direzione prendere; ma per quelli non abituali è sempre un grosso problema non sapere se il treno è quello che va nella direzione giusta. Quando io prendo la metropolitana trovo sempre (sempre) persone che mi chiedono informazioni, io mi guardo in giro e le informazioni sono diventate davvero difficili da trovare, soprattutto sulle linee più nuove; va a finire che c’è tanta gente obbligata a risalire le scale e andare sulla banchina opposta, il che può costare caro in termini di tempo, di appuntamenti, di coincidenze ferroviarie. Queste informazioni dovrebbero essere ovunque, e dovrebbero essere – come si dice – a misura di idiota. L’idiota per il test, se volete, mi offro di farlo io: è un ruolo nel quale mi sento perfettamente a mio agio, e con i tempi che corrono (e con i dirigenti e politici che mi tocca sopportare, che hanno scritto questi regolamenti e queste leggi, e che i miei compatrioti hanno ripetutamente eletto) essere un idiota mi sembra che venga sempre più assomigliare ad un titolo onorifico.
(nelle immagini: una cartolina milanese ritrovata su internet, Folon a Firenze con una sua scultura, e qui sopra un disegno famoso di Folon)
Il libro è Marc Augé, “Non luoghi – Introduzione ad un’antropologia della surmodernità”, editore Eleuthera, pag. 111, lire sedicimila: il fatto che il prezzo sia ancora in lire è dovuto al fatto che si tratta di un mio appunto ormai quasi ventennale, e direi che rende bene l’idea del tempo che è passato, per l’appunto quasi vent’anni.
Nel frattempo, che cosa è successo? E’ successo questo, che qualcuno ha pensato di intervenire sui “non-luoghi” cercando di renderli un po’ meno anonimi, un po’ meno impersonali; ed è stato un gravissimo errore, perché non è detto che i non-luoghi siano di per sè cose brutte. L’importante è la pulizia, in primo luogo; che ci si possa sedere, per esempio. E poi la sicurezza, certamente; ma senza esagerare, come purtroppo è successo e succede (anche con casi gravi, purtroppo, sia come invasione della nostra privacy che per cose peggiori). Ma riempire ogni spazio con musica e pubblicità, come si è fatto di recente, è davvero un rimedio peggiore del male: innanzitutto, perché non si deve imporre di ascoltare qualcosa a chi non è interessato ad ascoltarla. A casa mia, se arriva qualcuno spengo la tv o abbasso il volume della musica che sto ascoltando: al limite chiedo se piace, magari accendo il registratore, evito comunque di imporre agli altri qualcosa che gli altri non hanno voglia di ascoltare. Mi sembra il livello minimo della decenza, e della buona educazione.
Invece, non è andata così; per consolarmi, metto qui sotto un altro brano che parla della metropolitana, sperando che siano in arrivo tempi migliori. Si tratta di un grandissimo artista, è un brano a cui sono molto affezionato, e sono contento di poterlo rimettere in circolazione.
«Ho un figlio. E’ un bambino ritardato, vive in una casa di cura con altri diciotto bambini. Io me ne occupo molto e lui mi dà molto, richiede attenzioni e amore, io gliene dò e questo mi permette di restare un bambino, di esprimermi in modo semplice e chiaro. Non parlo di solito di questo, non c’è niente da dire e non c’è niente da nascondere, è la vita. Gli ho telefonato ieri, e mi ha chiesto se a New York avevo preso la metropolitana, se era silenziosa come quella di Parigi, se era pulito; e io gli risposto “no, ci sono i graffiti ed è molto rumoroso”. E lui ha concluso che era la stessa cosa. Gli ho detto: “spero di tornare a New York per portarti a vedere l’esposizione”. Mi ha chiesto: “Che cosa c’è nel museo?” e io gli ho detto: “Un tempio egizio, i giardini cinesi, i battelli africani”; e lui mi ha risposto che preferiva il metrò. Allora verrò a New York il mese prossimo per mostrare il metrò a mio figlio. Lo amo molto, lui ama guardare la vita e io non potrei vederla senza di lui.» (Jean Michel Folon, intervista con Luciana Capetti da L’Europeo 21 aprile 1990)
I gestori odierni della Metropolitana, oltre ai restyling chiassosi (da locale disco o da videogame) ci hanno regalato autentiche finezze burocratiche: ai tornelli non basta più obliterare, adesso devi indovinare dove devi obliterare (siamo dunque all’arzigogolo, ma temo che non sia ancora finita). I passeggeri abituali – mi sembra quasi inutile dirlo ma non si sa mai - lo sanno da per loro (milanesismo dialettale), così come sanno schivare i pilastri, e sanno dove scendere fino ai binari e che direzione prendere; ma per quelli non abituali è sempre un grosso problema non sapere se il treno è quello che va nella direzione giusta. Quando io prendo la metropolitana trovo sempre (sempre) persone che mi chiedono informazioni, io mi guardo in giro e le informazioni sono diventate davvero difficili da trovare, soprattutto sulle linee più nuove; va a finire che c’è tanta gente obbligata a risalire le scale e andare sulla banchina opposta, il che può costare caro in termini di tempo, di appuntamenti, di coincidenze ferroviarie. Queste informazioni dovrebbero essere ovunque, e dovrebbero essere – come si dice – a misura di idiota. L’idiota per il test, se volete, mi offro di farlo io: è un ruolo nel quale mi sento perfettamente a mio agio, e con i tempi che corrono (e con i dirigenti e politici che mi tocca sopportare, che hanno scritto questi regolamenti e queste leggi, e che i miei compatrioti hanno ripetutamente eletto) essere un idiota mi sembra che venga sempre più assomigliare ad un titolo onorifico.
(nelle immagini: una cartolina milanese ritrovata su internet, Folon a Firenze con una sua scultura, e qui sopra un disegno famoso di Folon)
domenica 25 marzo 2012
Metropolitana ( I )
Sulla metropolitana si è scritto molto, ci sono tante cose da leggere e da vedere (Dino Buzzati aveva collocato nella metropolitana milanese l’ingresso degli inferi: è in “Poema a fumetti”, metà anni ‘60). E quindi passo volentieri la mano, caso mai aggiungo qualche mia osservazione alla fine.
NEL METRÒ PARIGINO CON JULIO CORTÀZAR
di Julio Cortàzar, da La Repubblica 5 febbraio 2012
Il testo che anticipiamo è tratto da “Carte inaspettate”, raccolta di testi inediti di Cortazar (317 pagine, 20 euro) che Einaudi pubblica con prefazione di Antonio Tabucchi. In libreria dal 7 febbraio.
Può darsi che ancora una volta all'origine delle cose ci siano le parole, che il lessico dei treni metropolitani sia in parte la spiegazione di quel contatto permanente che mantengo con il metrò, e che da lì provengano le tante pagine che io gli ho dedicato o lui ha dedicato a me in racconti e romanzi, boomerang del verbo che torna alla mano e agli occhi. “Correspondance”, per esempio, è il termine che indica le corrispondenze tra le linee della metropolitana parigina, ma come quasi tutta la nomenclatura del nostro Ade urbano, è un termine carico. Quando arrivai a Parigi nel 1949, portando con me la bussola della letteratura francese, la mia guida era Charles Baudelaire. Il primo giorno volli conoscere l'Hótel Pimodan, nell'Ile SaintLouis, e quando domandai quale metrò portava in riva alla Senna, il padrone del mio albergo mi indicò la linea e aggiunse: -Non è difficile, c'è una sola correspondance-. In quel momento la mia mente tornò al celebre sonetto di Baudelaire e di colpo sentii che tutto filava liscio, fra me e Parigi non ci sarebbero stati problemi. Sono trascorsi ventinove anni e le corrispondenze fra noi persistono e aumentano. In Inghilterra e negli Stati Uniti, le corrispondenze si chiamano changes e nel mio paese combinaciones. Ognuna di queste tre parole contiene una carica analoga, suggerisce una mutazione, una trasformazione, una metamorfosi. L'uomo che scende nel metrò non è lo stesso che torna in superficie; tuttavia, bisogna che si sia tenuto l'obolo trai denti, che abbia meritato quello spostamento che per molti altri non è che un viaggio tra diverse stazioni, un oblio immediato.
In principio ci furono gli odori. Io avevo otto o nove anni, e dalla periferia di Buenos Aires dove vivevamo mia nonna mi portava in visita da certi amici. Si cominciava con un treno locale, dopo si prendeva un tram e infine, già in centro città, il metrò, che gli abitanti chiamano «subte», come se avessero paura della parola completa e volessero neutralizzarla mediante un taglio desacralizzante. Oggi so che quel percorso in metropolitana non durava più di venti minuti, ma allora lo vivevo come un viaggio interminabile nel quale tutto era meraviglioso dal momento stesso in cui si scendeva nella penombra della stazione. Respirare quell'odore che si sente solo nei metrò, un odore diverso in ogni città.
Mia nonna mi teneva per mano (il suo vestito nero, il cappello di paglia con la veletta che le copriva il viso, la sua invariabile tenerezza), e c'erano quei minuti di attesa sul binario quando vedevo la profondità del tunnel perdersi nel nulla, i semafori rossi e verdi nell'oscurità, e poi il fragore crescente, il treno dragone che ruggiva e sferragliava, i sedili di legno che rifiutavo per restarmene in piedi accanto al finestrino con la faccia incollata al vetro. Quando il treno prendeva velocità le pareti del tunnel si animavano, diventavano uno schermo mobile con cavi come serpenti neri ondeggianti al ritmo sincopato delle luci, e sempre quell'odore nell'aria spessa e lenta che nulla aveva a che vedere con quella di fuori. In un momento che mi sembrava meraviglioso, il treno risaliva in superficie, i finestrini si riempivano di sole e di fogliame; era al contempo il sollievo dopo la breve stagione all'inferno e la monotonia di tornare alla normalità, la strada, la gente, il tè coi pasticcini che ci aspettava invariabile a ogni visita mensile. Ma potevo sempre dirmi che il viaggio non era finito, la sera avrei ripreso il metrò, di nuovo il tunnel, i serpenti e l'odore, ancora quell'interregno eccezionale che in qualche modo mi condannava a scrivere cose come questa, cinquant'anni dopo.
E’ per cose come questa si può mantenere un commercio furtivo con il metrò, una relazione silenziosa che a volte ricompare nei sogni e in quell'altro modo di sognare che sono i racconti fantastici. In tali racconti e in alcune pagine di romanzi si è coagulato nel corso degli anni quel sentimento di passaggio che non ha nulla a che vedere con lo spostamento fisico da una stazione all'altra. (...)
Come a teatro o al cinema, nel metrò è sempre notte. Ma la sua notte non ha l'ordine circoscritto, il tempo scandito e l'atmosfera artificialmente piacevole delle sale da spettacolo. La notte del metrò è soffocante, umida come una serra e inoltre infinita, in qualsiasi punto e a qualsiasi ora sentiremo il suo prolungarsi nei tentacoli dei tunnel, in qualsiasi stazione pulserà uno dei molti cuori dell'immensa piovra nera che abbraccia la città. La notte del metrò non ha né inizio né fine, tutto si connette e si travasa, le stazioni terminal sono di arrivo e di partenza e chiamarle terminal è una forma di difesa contro l'indefinibile timore che ci aspetta nella penombra del primo corridoio, del primo binario. Il metrò come mediatore fra la routine condizionante della strada e la momentanea comparsa di altri stati di coscienza.
A differenza della strada, dove le opzioni e la vigilanza sono incessanti, basta iniziare la discesa perché una mano invisibile s'impadronisca della nostra e ci conduca senza alcuna possibilità di scelta verso la destinazione prefissata. Non si va in due modi diversi dalla stazione Étienne Marcel alla stazione Ranelagh: divieti, passaggi, cartelli e scale annullano ogni possibilità di capriccio, ogni zigzag da superficie. Passeggeri e treni si muovono all'interno della stessa orologeria predeterminata, ed è allora che le potenze della superficie si addormentano e cominciamo a sprofondare in altri livelli. Affrancandoci dalla libertà, il metrò ci rende temporaneamente disponibili, porosi, aperti a tutto ciò che la libertà della superficie ci toglie, poiché essere liberi lassù comporta pericolo, inevitabili scelte, semaforo rosso, attraversare gli incroci guardando dalla parte giusta.
Se fossero vissuti nel nostro tempo, poeti come Gérard de Nerval e Baudelaire avrebbero amato il metrò; Nerval per l'aspetto allucinatorio, ciclico e ricorrente, Baudelaire per il carattere totalmente artificioso di una micropoli dove non ci sono piante, uccelli o cani (ratti sì, ma il ratto è dalla parte del poeta, lotta contro il sistema, lo mina e lo contamina in una battaglia feroce che dura fin dalla prima città degli uomini e durerà fino all'ultima). (...)
I volti dei passeggeri di un autobus riflettono sempre qualcosa di ciò che li circonda e invade attraverso i finestrini, i loro occhi si lasciano distrarre dai cartelli pubblicitari, dal passaggio delle automobili, dal ritmo delle vetrine, dai passanti sul marciapiede. Invece nel metrò tutto diventa rigido e senza tempo, non c'è niente da vedere, da odorare o da ascoltare, la vita è ricorrente, ciclica, forzosa e quasi identica in ogni stazione. I cartelloni pubblicitari durano in eterno e forse nessuno si rende conto che periodicamente cambiano. La luce e l'aria hanno sempre la stessa consistenza, tutti abbiamo letto centinaia di volte le avvertenze, i divieti e le istruzioni municipali, e continueremo a leggerli perché nel metrò gli occhi hanno sempre fame, cercano un impiego, qualcosa che li distragga da quell'andare e venire nel nulla. (...)
Paradossalmente, la codificazione fredda e immutabile del metrò favorisce in alcuni passeggeri l'irruzione dell'insolito. Sappiamo della disponibilità, della porosità creata dalla routine, della sonnolenza indotta da indicazioni e percorsi risaputi. Il solito è talmente sottolineato che la minima trasgressione si manifesta con una forza impensabile in superficie. (...)
D'altra parte, la rottura della monotonia può nascere da quello stato di ozio mentale che il metrò favorisce come poche altre situazioni. Penso a un mio racconto, ancora inedito, che nasce da un commento umoristico sul numero di passeggeri che un certo giorno erano scesi al subte Anglo a Buenos Aires e di quanti erano tornati in superficie (ne mancava uno). Uno scherzo, un errore, tutto tendeva a minimizzare un episodio che, tuttavia, mi sembrava grave, forse orribile, e che nella sua proiezione immaginaria diventava il preludio di una scoperta abominevole. E poi c'è quel fascino che il passeggero funzionale e frettoloso ignora, il richiamo più profondo, l'invito a restare, a essere metrò. Si tratta ancora una volta dell'attrazione del labirinto, ricorrente maelstrom di pietra e di metallo. L'insolito vi si esprime come un richiamo che esige la rinuncia alla superficie, la ricodificazione della vita. Poveri Ulisse legati dall'urgenza degli orari e degli appuntamenti, i passeggeri si tappano le orecchie con ogni tipo di oggetti o esercitandosi nella vuota contemplazione della carrozza o del binario. Alcuni, però, ascoltano il canto delle sirene degli abissi e io ho imparato a riconoscerli, sono quelli che mentre aspettano un treno voltano la schiena alla stazione e fissano le tenebre del tunnel. (...)
«Raster», Amsterdam, n. 12,1980. © Heirs of Julio Cortazar, 2009 ©Aurora Bernardez and Carles Alvarez Garriga, 2009 Edition prepared by Aurora Bernardez and Carles Alvarez Garriga(Traduzione di Jaime Riera Rehren)
Cortàzar scriveva questo testo nel 1980; scrivere oggi qualcosa di simile sarebbe impossibile perchè la pubblicità, anche nel metrò, si è fatta violenta e invasiva. Non è più possibile stare con i propri pensieri, fantasticare aspettando che arrivi il treno, anche leggere un libro o il giornale è diventato difficile. Dai teleschermi arrivano cose insulse e senza alcuna pausa, dal metrò non ci si può allontanare, magari si potesse ascoltare il canto delle sirene. In più, nel recentissimo “restyling” i colori della metropolitana milanese sono diventati più accesi, quasi violenti. Nei primi anni ’60 si era cercato di rendere almeno un po’ confortevole l’ambiente sotterraneo, oggi prevale l’ambiente da videogame; e mi ha fatto quasi sorridere leggere, un paio d’anni fa, che perfino il sindaco di allora (Letizia Moratti: notizia reperibile su Repubblica 20.03.2009) sarebbe stata favorevole a un ripristino dell’arredo originale di Bob Noorda (nell'occasione, venne interpellato lo stesso Noorda, che abita a Milano, e che si dichiarò disponibilissimo). Ma qui sorvolo, rinvio alla prossima puntata, e metto qualche riga su Cortàzar, sempre presa da La Repubblica 5 febbraio 2012
Julio Cortàzar nasce in Belgio nel 1914; il padre è un diplomatico argentino. Torna nel paese d’origine a quattro anni. Diventerà professore di Lettere, poi inizierà a studiare filosofia. Nel 1946 pubblica su Los Anales di Borges “Il gioco del mondo” (1963) è il romanzo della consacrazione. “Il Persecutore” ha per protagonista il jazzista Charlie Parker. Dona i diritti delle sue opere per aiutare i prigionieri politici di varie nazioni. Avversa il peronismo, viaggia in Cile e Nicaragua. Muore a Parigi, la città dove vive di più, nel 1984. “Le bave del diavolo” ispira Antonioni per il film Blow-Up. “L'autostrada del Sud” è alla base di Weekend di Godard. E anche Il persecutore è diventato un film in Argentina
(le immagini della metropolitana milanese in costruzione, in zona centralissima, vengono da “Il posto” di Ermanno Olmi, film del 1961)
NEL METRÒ PARIGINO CON JULIO CORTÀZAR
di Julio Cortàzar, da La Repubblica 5 febbraio 2012
Il testo che anticipiamo è tratto da “Carte inaspettate”, raccolta di testi inediti di Cortazar (317 pagine, 20 euro) che Einaudi pubblica con prefazione di Antonio Tabucchi. In libreria dal 7 febbraio.
Può darsi che ancora una volta all'origine delle cose ci siano le parole, che il lessico dei treni metropolitani sia in parte la spiegazione di quel contatto permanente che mantengo con il metrò, e che da lì provengano le tante pagine che io gli ho dedicato o lui ha dedicato a me in racconti e romanzi, boomerang del verbo che torna alla mano e agli occhi. “Correspondance”, per esempio, è il termine che indica le corrispondenze tra le linee della metropolitana parigina, ma come quasi tutta la nomenclatura del nostro Ade urbano, è un termine carico. Quando arrivai a Parigi nel 1949, portando con me la bussola della letteratura francese, la mia guida era Charles Baudelaire. Il primo giorno volli conoscere l'Hótel Pimodan, nell'Ile SaintLouis, e quando domandai quale metrò portava in riva alla Senna, il padrone del mio albergo mi indicò la linea e aggiunse: -Non è difficile, c'è una sola correspondance-. In quel momento la mia mente tornò al celebre sonetto di Baudelaire e di colpo sentii che tutto filava liscio, fra me e Parigi non ci sarebbero stati problemi. Sono trascorsi ventinove anni e le corrispondenze fra noi persistono e aumentano. In Inghilterra e negli Stati Uniti, le corrispondenze si chiamano changes e nel mio paese combinaciones. Ognuna di queste tre parole contiene una carica analoga, suggerisce una mutazione, una trasformazione, una metamorfosi. L'uomo che scende nel metrò non è lo stesso che torna in superficie; tuttavia, bisogna che si sia tenuto l'obolo trai denti, che abbia meritato quello spostamento che per molti altri non è che un viaggio tra diverse stazioni, un oblio immediato.
In principio ci furono gli odori. Io avevo otto o nove anni, e dalla periferia di Buenos Aires dove vivevamo mia nonna mi portava in visita da certi amici. Si cominciava con un treno locale, dopo si prendeva un tram e infine, già in centro città, il metrò, che gli abitanti chiamano «subte», come se avessero paura della parola completa e volessero neutralizzarla mediante un taglio desacralizzante. Oggi so che quel percorso in metropolitana non durava più di venti minuti, ma allora lo vivevo come un viaggio interminabile nel quale tutto era meraviglioso dal momento stesso in cui si scendeva nella penombra della stazione. Respirare quell'odore che si sente solo nei metrò, un odore diverso in ogni città.
Mia nonna mi teneva per mano (il suo vestito nero, il cappello di paglia con la veletta che le copriva il viso, la sua invariabile tenerezza), e c'erano quei minuti di attesa sul binario quando vedevo la profondità del tunnel perdersi nel nulla, i semafori rossi e verdi nell'oscurità, e poi il fragore crescente, il treno dragone che ruggiva e sferragliava, i sedili di legno che rifiutavo per restarmene in piedi accanto al finestrino con la faccia incollata al vetro. Quando il treno prendeva velocità le pareti del tunnel si animavano, diventavano uno schermo mobile con cavi come serpenti neri ondeggianti al ritmo sincopato delle luci, e sempre quell'odore nell'aria spessa e lenta che nulla aveva a che vedere con quella di fuori. In un momento che mi sembrava meraviglioso, il treno risaliva in superficie, i finestrini si riempivano di sole e di fogliame; era al contempo il sollievo dopo la breve stagione all'inferno e la monotonia di tornare alla normalità, la strada, la gente, il tè coi pasticcini che ci aspettava invariabile a ogni visita mensile. Ma potevo sempre dirmi che il viaggio non era finito, la sera avrei ripreso il metrò, di nuovo il tunnel, i serpenti e l'odore, ancora quell'interregno eccezionale che in qualche modo mi condannava a scrivere cose come questa, cinquant'anni dopo.
E’ per cose come questa si può mantenere un commercio furtivo con il metrò, una relazione silenziosa che a volte ricompare nei sogni e in quell'altro modo di sognare che sono i racconti fantastici. In tali racconti e in alcune pagine di romanzi si è coagulato nel corso degli anni quel sentimento di passaggio che non ha nulla a che vedere con lo spostamento fisico da una stazione all'altra. (...)
Come a teatro o al cinema, nel metrò è sempre notte. Ma la sua notte non ha l'ordine circoscritto, il tempo scandito e l'atmosfera artificialmente piacevole delle sale da spettacolo. La notte del metrò è soffocante, umida come una serra e inoltre infinita, in qualsiasi punto e a qualsiasi ora sentiremo il suo prolungarsi nei tentacoli dei tunnel, in qualsiasi stazione pulserà uno dei molti cuori dell'immensa piovra nera che abbraccia la città. La notte del metrò non ha né inizio né fine, tutto si connette e si travasa, le stazioni terminal sono di arrivo e di partenza e chiamarle terminal è una forma di difesa contro l'indefinibile timore che ci aspetta nella penombra del primo corridoio, del primo binario. Il metrò come mediatore fra la routine condizionante della strada e la momentanea comparsa di altri stati di coscienza.
A differenza della strada, dove le opzioni e la vigilanza sono incessanti, basta iniziare la discesa perché una mano invisibile s'impadronisca della nostra e ci conduca senza alcuna possibilità di scelta verso la destinazione prefissata. Non si va in due modi diversi dalla stazione Étienne Marcel alla stazione Ranelagh: divieti, passaggi, cartelli e scale annullano ogni possibilità di capriccio, ogni zigzag da superficie. Passeggeri e treni si muovono all'interno della stessa orologeria predeterminata, ed è allora che le potenze della superficie si addormentano e cominciamo a sprofondare in altri livelli. Affrancandoci dalla libertà, il metrò ci rende temporaneamente disponibili, porosi, aperti a tutto ciò che la libertà della superficie ci toglie, poiché essere liberi lassù comporta pericolo, inevitabili scelte, semaforo rosso, attraversare gli incroci guardando dalla parte giusta.
Se fossero vissuti nel nostro tempo, poeti come Gérard de Nerval e Baudelaire avrebbero amato il metrò; Nerval per l'aspetto allucinatorio, ciclico e ricorrente, Baudelaire per il carattere totalmente artificioso di una micropoli dove non ci sono piante, uccelli o cani (ratti sì, ma il ratto è dalla parte del poeta, lotta contro il sistema, lo mina e lo contamina in una battaglia feroce che dura fin dalla prima città degli uomini e durerà fino all'ultima). (...)
I volti dei passeggeri di un autobus riflettono sempre qualcosa di ciò che li circonda e invade attraverso i finestrini, i loro occhi si lasciano distrarre dai cartelli pubblicitari, dal passaggio delle automobili, dal ritmo delle vetrine, dai passanti sul marciapiede. Invece nel metrò tutto diventa rigido e senza tempo, non c'è niente da vedere, da odorare o da ascoltare, la vita è ricorrente, ciclica, forzosa e quasi identica in ogni stazione. I cartelloni pubblicitari durano in eterno e forse nessuno si rende conto che periodicamente cambiano. La luce e l'aria hanno sempre la stessa consistenza, tutti abbiamo letto centinaia di volte le avvertenze, i divieti e le istruzioni municipali, e continueremo a leggerli perché nel metrò gli occhi hanno sempre fame, cercano un impiego, qualcosa che li distragga da quell'andare e venire nel nulla. (...)
Paradossalmente, la codificazione fredda e immutabile del metrò favorisce in alcuni passeggeri l'irruzione dell'insolito. Sappiamo della disponibilità, della porosità creata dalla routine, della sonnolenza indotta da indicazioni e percorsi risaputi. Il solito è talmente sottolineato che la minima trasgressione si manifesta con una forza impensabile in superficie. (...)
D'altra parte, la rottura della monotonia può nascere da quello stato di ozio mentale che il metrò favorisce come poche altre situazioni. Penso a un mio racconto, ancora inedito, che nasce da un commento umoristico sul numero di passeggeri che un certo giorno erano scesi al subte Anglo a Buenos Aires e di quanti erano tornati in superficie (ne mancava uno). Uno scherzo, un errore, tutto tendeva a minimizzare un episodio che, tuttavia, mi sembrava grave, forse orribile, e che nella sua proiezione immaginaria diventava il preludio di una scoperta abominevole. E poi c'è quel fascino che il passeggero funzionale e frettoloso ignora, il richiamo più profondo, l'invito a restare, a essere metrò. Si tratta ancora una volta dell'attrazione del labirinto, ricorrente maelstrom di pietra e di metallo. L'insolito vi si esprime come un richiamo che esige la rinuncia alla superficie, la ricodificazione della vita. Poveri Ulisse legati dall'urgenza degli orari e degli appuntamenti, i passeggeri si tappano le orecchie con ogni tipo di oggetti o esercitandosi nella vuota contemplazione della carrozza o del binario. Alcuni, però, ascoltano il canto delle sirene degli abissi e io ho imparato a riconoscerli, sono quelli che mentre aspettano un treno voltano la schiena alla stazione e fissano le tenebre del tunnel. (...)
«Raster», Amsterdam, n. 12,1980. © Heirs of Julio Cortazar, 2009 ©Aurora Bernardez and Carles Alvarez Garriga, 2009 Edition prepared by Aurora Bernardez and Carles Alvarez Garriga(Traduzione di Jaime Riera Rehren)
Cortàzar scriveva questo testo nel 1980; scrivere oggi qualcosa di simile sarebbe impossibile perchè la pubblicità, anche nel metrò, si è fatta violenta e invasiva. Non è più possibile stare con i propri pensieri, fantasticare aspettando che arrivi il treno, anche leggere un libro o il giornale è diventato difficile. Dai teleschermi arrivano cose insulse e senza alcuna pausa, dal metrò non ci si può allontanare, magari si potesse ascoltare il canto delle sirene. In più, nel recentissimo “restyling” i colori della metropolitana milanese sono diventati più accesi, quasi violenti. Nei primi anni ’60 si era cercato di rendere almeno un po’ confortevole l’ambiente sotterraneo, oggi prevale l’ambiente da videogame; e mi ha fatto quasi sorridere leggere, un paio d’anni fa, che perfino il sindaco di allora (Letizia Moratti: notizia reperibile su Repubblica 20.03.2009) sarebbe stata favorevole a un ripristino dell’arredo originale di Bob Noorda (nell'occasione, venne interpellato lo stesso Noorda, che abita a Milano, e che si dichiarò disponibilissimo). Ma qui sorvolo, rinvio alla prossima puntata, e metto qualche riga su Cortàzar, sempre presa da La Repubblica 5 febbraio 2012
Julio Cortàzar nasce in Belgio nel 1914; il padre è un diplomatico argentino. Torna nel paese d’origine a quattro anni. Diventerà professore di Lettere, poi inizierà a studiare filosofia. Nel 1946 pubblica su Los Anales di Borges “Il gioco del mondo” (1963) è il romanzo della consacrazione. “Il Persecutore” ha per protagonista il jazzista Charlie Parker. Dona i diritti delle sue opere per aiutare i prigionieri politici di varie nazioni. Avversa il peronismo, viaggia in Cile e Nicaragua. Muore a Parigi, la città dove vive di più, nel 1984. “Le bave del diavolo” ispira Antonioni per il film Blow-Up. “L'autostrada del Sud” è alla base di Weekend di Godard. E anche Il persecutore è diventato un film in Argentina
(le immagini della metropolitana milanese in costruzione, in zona centralissima, vengono da “Il posto” di Ermanno Olmi, film del 1961)
giovedì 22 marzo 2012
Stazione Centrale
Arrivato davanti alla Stazione Centrale comincio a rendermi conto che questo mio piccolo giro per Milano sta diventando quasi una via crucis, e me ne scuso ma in fin dei conti non è colpa mia. Non è colpa mia, intendo, se negli ultimi dieci o quindici anni si sono fatte tante devastazioni e tanti errori, alcuni dei quali ormai irrimediabili. Davanti alla Stazione Centrale mi viene da piangere e da scappar via, ma invece cerco di ricompormi e di mettere almeno un po’ d’ordine in quello che sto pensando.
La Stazione Centrale di Milano è sempre stata brutta, e questo lo si sapeva da tempo; per quanto mi riguarda, l’ho trovata così, e pazienza. A renderla bella, infatti, ci pensava la gente che ci stava dentro: le persone, uomini donne e bambini, quelli di passaggio, i viaggiatori, e quelli che ci lavoravano dentro, bigliettai, ferrovieri, edicolanti, bar e panini, e via elencando. La Stazione Centrale, come tutte le stazioni, era un posto accogliente e pieno di vita, e che fosse brutta era ormai un fatto secondario. Era anche un po’ scomoda, oltre che brutta, con quelle enormi scalinate, quei marmi, ma in fin dei conti la scala mobile portava diritta ai binari, non c’era bisogno di fermarsi e guardarsi in giro. So che c’è qualcuno a cui piace la Stazione Centrale, non solo gli interni ma anche vista dal di fuori, da lontano; io invece so come sono le stazioni vere, qualcuna l’ho visitata, altre le ho viste al cinema, in fotografia. Per fare solo qualche esempio, sono magnifiche quelle americane, altrettanto antiche, che si vedono in “Witness” di Peter Weir o in “Mystery train” di Jim Jarmusch; bellissime anche molte europee, in Svizzera, in Finlandia, l’elenco sarebbe infinito. A noi milanesi invece ci è toccata questa cosa qua, forse ce la siamo anche meritata, ma in fin dei conti la sua funzione la svolgeva, e pazienza.
Pochi, pochissimi anni fa, hanno fatto un restyling: non solo qui, ma un po’ in tutte le stazioni. Lì per lì mi ero detto “bene, se dalla metropolitana si arriva direttamente alla Stazione dev’essere un buon progetto”, e invece la realtà si sarebbe rivelata diversa.
La realtà è questa, ormai visibile a tutti: 1) le biglietterie, che prima erano nell’ingresso, ora sono lontanissime e bisogna camminare un bel po’ per raggiungerle. Dal solerte ufficio stampa è arrivata pronta una risposta: che il biglietto oggi si può fare comodamente via internet. Ma se è una cosa è comoda per me, vorrei essere io a deciderlo. Io ero e sono comodissimo con la biglietteria, oltretutto i bigliettai davano sempre informazioni, risolvevano dubbi, le macchinette invece non lo fanno e a me non piace passare la mia vita a litigare con una macchinetta che non dà il resto alle mie cinquanta euro se il biglietto ne costa dodici. 2) la scale mobili, che prima portavano direttamente ai binari, non ci sono più. Ora ci sono i tapis roulant, modernissimi, meravigliosi, ma che avvolgono come un pitone tutta la stazione: volete arrivare ai binari, o voi passeggeri? Ci vorrà almeno un quarto d’ora, perché prima dovete guardare le vetrine. E non lamentatevi: solo i tamarri vanno di corsa a prendere il treno e solo un tamarro non ha soldi da spendere. 3) sparite le sale d’attesa: giusto qualche seggiola qui e là. Le sale d’attesa ci sono, ma per entrarci bisogna pagare e avere un’apposita tesserina che certifichi di non essere un tamarro. 4) sparite anche le toilettes, nel senso che è tutto a pagamento e senza personale. Non avete la moneta, non avete l’apposita tesserina del club? Ve la potete anche fare addosso, voi tamarri e i vostri bambini (tamarri anche loro, naturalmente). 5) teleschermi e pubblicità ovunque, in ogni angolo, a volume altissimo, ventiquattrore su ventiquattro.
Vado avanti? no, mi fermo, ce n’è abbastanza e chi viaggia sa bene cosa aggiungere: i tagli alle corse e gli aumenti dei prezzi dei biglietti, per esempio, ma on line ci sono molti siti pieni di esempi e di fatti, con numerose testimonianze di viaggiatori e pendolari esasperati. Non che prima viaggiare fosse facile, ma prima c’era pur sempre questo: che le stazioni e i treni erano pensati e costruiti intorno ai passeggeri, e non viceversa. Anche il treno più brutto e scassato, anche la stazione più polverosa e invivibile, erano comunque residuo di qualcosa che era stato pensato per facilitare il viaggio.
Che in un periodo di crisi economica, di tagli sanguinosi e di bilanci pubblici da risanare si trovino i soldi per queste opere, per i Restyling per i Grattacieli, per le Nuove Sedi della Regione e per le Grandi Opere Inutili, è un fatto davvero strano, ma vedo che su queste cose sta indagando la magistratura, il fatto dunque comincia ad essere un po’ meno strano e quindi mi fermo (così evito anche querele, o peggio: c’è gente molto cattiva in giro).
Queste opere recenti servono quasi soltanto a mettere in mostra l’ego dei politici e degli architetti, il “sono stato qui”, il lasciare la propria firma come un graffito sugli affreschi di Leonardo, in eterno. Il sogno dei sindaci e dei governatori del Duemila è costruire enormi grattacieli che si vedano anche da lontano, “rovesciare la città come un calzino”, fare in modo che la gente non si dimentichi più di te, più o meno come avvenne al tempo della costruzione della Stazione Centrale. Servirebbero invece strutture accoglienti e ben pensate, che vadano ad armonizzarsi con l’esistente; e invece dei costosissimi restyling il più delle volte basterebbe un’imbiancatura, la messa in sicurezza degli impianti, l’ordinaria manutenzione, queste cose qui.
Se si voleva trasformare la Stazione Centrale in un centro commerciale, era comunque possibile farlo e io non mi sarei opposto: lo si è fatto altrove, in Francia per esempio dove c’era una stazione oggi c’è un museo importante. Lo si poteva fare, bastava costruire una stazione nuova.
C’è qualcosa in più da dire? No, direi di no: Milano si merita una bella stazione, aperta, accogliente.
Vorrei comunque concludere con qualcosa di positivo, e cioè un ricordo di quello che si poteva fare fino a ieri, avendo diciott’anni e un po’ di soldi in tasca. Lo scrivo perché questo post rischia di essere incomprensibile per i sedicenni e i diciottenni del 2012: in treno si facevano amicizie, si poteva parlare con la gente, qualche volta le amicizie duravano nel tempo. Per esempio, una volta che andavo a Firenze partendo dalla Stazione Centrale mi sono trovato lo scompartimento invaso da cinque ragazze del liceo tedesco di Milano, tedesche ma milanesi, una di loro si è accorta che io capivo qualcosa di quel che dicevo e lo ha detto alle sue amiche, “state attenti che lui capisce”, e mi dispiace che la cosa non abbia avuto seguito (in questo caso no, in altre sì). Oggi, se avessi diciott’anni, mi troverei invece davanti a un muro di ipad, di smartphone e di cuffiette nelle orecchie, e forse è per questo che nessuno si è ancora ribellato ai padroni delle stazioni e ai loro regolamenti incivili.
La Stazione Centrale di Milano è sempre stata brutta, e questo lo si sapeva da tempo; per quanto mi riguarda, l’ho trovata così, e pazienza. A renderla bella, infatti, ci pensava la gente che ci stava dentro: le persone, uomini donne e bambini, quelli di passaggio, i viaggiatori, e quelli che ci lavoravano dentro, bigliettai, ferrovieri, edicolanti, bar e panini, e via elencando. La Stazione Centrale, come tutte le stazioni, era un posto accogliente e pieno di vita, e che fosse brutta era ormai un fatto secondario. Era anche un po’ scomoda, oltre che brutta, con quelle enormi scalinate, quei marmi, ma in fin dei conti la scala mobile portava diritta ai binari, non c’era bisogno di fermarsi e guardarsi in giro. So che c’è qualcuno a cui piace la Stazione Centrale, non solo gli interni ma anche vista dal di fuori, da lontano; io invece so come sono le stazioni vere, qualcuna l’ho visitata, altre le ho viste al cinema, in fotografia. Per fare solo qualche esempio, sono magnifiche quelle americane, altrettanto antiche, che si vedono in “Witness” di Peter Weir o in “Mystery train” di Jim Jarmusch; bellissime anche molte europee, in Svizzera, in Finlandia, l’elenco sarebbe infinito. A noi milanesi invece ci è toccata questa cosa qua, forse ce la siamo anche meritata, ma in fin dei conti la sua funzione la svolgeva, e pazienza.
Pochi, pochissimi anni fa, hanno fatto un restyling: non solo qui, ma un po’ in tutte le stazioni. Lì per lì mi ero detto “bene, se dalla metropolitana si arriva direttamente alla Stazione dev’essere un buon progetto”, e invece la realtà si sarebbe rivelata diversa.
La realtà è questa, ormai visibile a tutti: 1) le biglietterie, che prima erano nell’ingresso, ora sono lontanissime e bisogna camminare un bel po’ per raggiungerle. Dal solerte ufficio stampa è arrivata pronta una risposta: che il biglietto oggi si può fare comodamente via internet. Ma se è una cosa è comoda per me, vorrei essere io a deciderlo. Io ero e sono comodissimo con la biglietteria, oltretutto i bigliettai davano sempre informazioni, risolvevano dubbi, le macchinette invece non lo fanno e a me non piace passare la mia vita a litigare con una macchinetta che non dà il resto alle mie cinquanta euro se il biglietto ne costa dodici. 2) la scale mobili, che prima portavano direttamente ai binari, non ci sono più. Ora ci sono i tapis roulant, modernissimi, meravigliosi, ma che avvolgono come un pitone tutta la stazione: volete arrivare ai binari, o voi passeggeri? Ci vorrà almeno un quarto d’ora, perché prima dovete guardare le vetrine. E non lamentatevi: solo i tamarri vanno di corsa a prendere il treno e solo un tamarro non ha soldi da spendere. 3) sparite le sale d’attesa: giusto qualche seggiola qui e là. Le sale d’attesa ci sono, ma per entrarci bisogna pagare e avere un’apposita tesserina che certifichi di non essere un tamarro. 4) sparite anche le toilettes, nel senso che è tutto a pagamento e senza personale. Non avete la moneta, non avete l’apposita tesserina del club? Ve la potete anche fare addosso, voi tamarri e i vostri bambini (tamarri anche loro, naturalmente). 5) teleschermi e pubblicità ovunque, in ogni angolo, a volume altissimo, ventiquattrore su ventiquattro.
Vado avanti? no, mi fermo, ce n’è abbastanza e chi viaggia sa bene cosa aggiungere: i tagli alle corse e gli aumenti dei prezzi dei biglietti, per esempio, ma on line ci sono molti siti pieni di esempi e di fatti, con numerose testimonianze di viaggiatori e pendolari esasperati. Non che prima viaggiare fosse facile, ma prima c’era pur sempre questo: che le stazioni e i treni erano pensati e costruiti intorno ai passeggeri, e non viceversa. Anche il treno più brutto e scassato, anche la stazione più polverosa e invivibile, erano comunque residuo di qualcosa che era stato pensato per facilitare il viaggio.
Che in un periodo di crisi economica, di tagli sanguinosi e di bilanci pubblici da risanare si trovino i soldi per queste opere, per i Restyling per i Grattacieli, per le Nuove Sedi della Regione e per le Grandi Opere Inutili, è un fatto davvero strano, ma vedo che su queste cose sta indagando la magistratura, il fatto dunque comincia ad essere un po’ meno strano e quindi mi fermo (così evito anche querele, o peggio: c’è gente molto cattiva in giro).
Queste opere recenti servono quasi soltanto a mettere in mostra l’ego dei politici e degli architetti, il “sono stato qui”, il lasciare la propria firma come un graffito sugli affreschi di Leonardo, in eterno. Il sogno dei sindaci e dei governatori del Duemila è costruire enormi grattacieli che si vedano anche da lontano, “rovesciare la città come un calzino”, fare in modo che la gente non si dimentichi più di te, più o meno come avvenne al tempo della costruzione della Stazione Centrale. Servirebbero invece strutture accoglienti e ben pensate, che vadano ad armonizzarsi con l’esistente; e invece dei costosissimi restyling il più delle volte basterebbe un’imbiancatura, la messa in sicurezza degli impianti, l’ordinaria manutenzione, queste cose qui.
Se si voleva trasformare la Stazione Centrale in un centro commerciale, era comunque possibile farlo e io non mi sarei opposto: lo si è fatto altrove, in Francia per esempio dove c’era una stazione oggi c’è un museo importante. Lo si poteva fare, bastava costruire una stazione nuova.
C’è qualcosa in più da dire? No, direi di no: Milano si merita una bella stazione, aperta, accogliente.
Vorrei comunque concludere con qualcosa di positivo, e cioè un ricordo di quello che si poteva fare fino a ieri, avendo diciott’anni e un po’ di soldi in tasca. Lo scrivo perché questo post rischia di essere incomprensibile per i sedicenni e i diciottenni del 2012: in treno si facevano amicizie, si poteva parlare con la gente, qualche volta le amicizie duravano nel tempo. Per esempio, una volta che andavo a Firenze partendo dalla Stazione Centrale mi sono trovato lo scompartimento invaso da cinque ragazze del liceo tedesco di Milano, tedesche ma milanesi, una di loro si è accorta che io capivo qualcosa di quel che dicevo e lo ha detto alle sue amiche, “state attenti che lui capisce”, e mi dispiace che la cosa non abbia avuto seguito (in questo caso no, in altre sì). Oggi, se avessi diciott’anni, mi troverei invece davanti a un muro di ipad, di smartphone e di cuffiette nelle orecchie, e forse è per questo che nessuno si è ancora ribellato ai padroni delle stazioni e ai loro regolamenti incivili.
(il film è "Witness", di Peter Weir; l'immagine in bianco e nero è la Stazione Centrale di Milano)
mercoledì 21 marzo 2012
Sant'Ambrogio
La chiesa dedicata a Sant’Ambrogio è stata per lungo tempo uno dei miei posti preferiti, a Milano. Il perché lo avrei capito molto tempo dopo le mie prime visite, leggendo Elemire Zolla (che a quei tempi pubblicava regolarmente sul Corriere della Sera). Il segreto, avrei scoperto, è nel romanico.
Da dove veniva quella sensazione di quiete, quel sentirmi a mio agio, che provavo a Sant’Ambrogio, e molto meno in Duomo? E’ un argomento di cui mi aveva parlato un professore a scuola, ma si sa che a scuola siamo sempre disattenti: il gotico dà l’idea di Dio come qualcosa di lontano, che incombe dall’alto, mentre il romanico (più antico, intorno all’anno Mille) è a misura d’uomo. E la chiesa di Sant’Ambrogio, a Milano, è proprio così: in mattoni, non altissima, con ampi spazi, perfino luminosa se paragonata al Duomo. Insomma, fin dal suo ingresso si vede che è un posto progettato e pensato per sedersi, pensare, pregare, un posto dove Dio finisce per essere più vicino a noi, farsi uomo, dove Dio lo si può immaginare ridere e soffrire con noi, uomo come noi, insomma, roba da Cristiani.
E’ anche per questo motivo, soprattutto per questo motivo, che qualche anno fa ho letto una notizia che mi ha riempito di sgomento: un grande parcheggio sotto Sant’Ambrogio. Mi sono detto subito che solo un pazzo o un imbecille potevano avere un pensiero simile, e invece la giunta comunale (Lega, ex Msi, Berlusconi) approvò subito il progetto, e in quattro e quattr’otto iniziarono i lavori.
Nel 2011, la nuova giunta comunale spiegò che fermare completamente il progetto era ormai impossibile, i contratti erano stati firmati, una parte dei lavori era già stata fatta, bloccando tutto si dovevano pagare penali elevatissime. Cosa fare?
Non so proprio cosa fare, ma al pensiero di un enorme cantiere in Sant’Ambrogio io sto male; e ogni volta che si alza qualcuno e spiega che non ci sono rischi a scavare sotto Sant’Ambrogio sto ancora più male. La cosa non è finita qui: è notizia di ieri che a Brescia (Lega, PDL, ex Msi) è stato approvato un piano simile, un enorme scavo sotto i luoghi storici della città; e a Firenze non so se il sindaco Renzi abbia bloccato il progetto del tram sotto il campanile di Giotto, e notizie simili ne arrivano un po’ dappertutto, sia sui monumenti e sulle chiese che su boschi e parchi e terreni agricoli. Intanto il dibattito ferve: non sulle nostre chiese e sul nostro paesaggio in pericolo, ma sulla costruzione delle moschee. Mi sta anche bene che si possa discutere delle moschee, ma per carità, qui abbiamo millenni di Storia alle nostre spalle, qui si sta distruggendo la nostra memoria.
Qualche notizia storica però devo darla: la chiesa fu davvero edificata da sant’Ambrogio, intorno al 379-386 d.C. Il luogo scelto fu quello di un sacrario dedicato ai primi martiri cristiani, e infatti la chiesa è ancora dedicata a loro.Le prime modifiche furono fatte dal vescovo Angilberto, tra l’824 e l’860; l’assetto attuale risale al 1088-1099, vescovo Anselmo. Una chiesa costruita con materiali poveri, come spiegano le guide: mattoni, legno, pietre, cose che si potevano trovare anche nei dintorni; e la bellezza semplice e profonda dello stile romanico.
Per il resto, la storia di Sant’Ambrogio è lunga e piena di avvenimenti, non escluso il bombardamento della seconda guerra mondiale; ma per queste notizie è meglio andarsi a cercare un libro di Storia: è quello che sto per fare anch’io, di curiosità me ne sono venute molte e non si finisce mai di imparare, e di ricordare.
(le immagini vengono da www.wikipedia.it )
Da dove veniva quella sensazione di quiete, quel sentirmi a mio agio, che provavo a Sant’Ambrogio, e molto meno in Duomo? E’ un argomento di cui mi aveva parlato un professore a scuola, ma si sa che a scuola siamo sempre disattenti: il gotico dà l’idea di Dio come qualcosa di lontano, che incombe dall’alto, mentre il romanico (più antico, intorno all’anno Mille) è a misura d’uomo. E la chiesa di Sant’Ambrogio, a Milano, è proprio così: in mattoni, non altissima, con ampi spazi, perfino luminosa se paragonata al Duomo. Insomma, fin dal suo ingresso si vede che è un posto progettato e pensato per sedersi, pensare, pregare, un posto dove Dio finisce per essere più vicino a noi, farsi uomo, dove Dio lo si può immaginare ridere e soffrire con noi, uomo come noi, insomma, roba da Cristiani.
E’ anche per questo motivo, soprattutto per questo motivo, che qualche anno fa ho letto una notizia che mi ha riempito di sgomento: un grande parcheggio sotto Sant’Ambrogio. Mi sono detto subito che solo un pazzo o un imbecille potevano avere un pensiero simile, e invece la giunta comunale (Lega, ex Msi, Berlusconi) approvò subito il progetto, e in quattro e quattr’otto iniziarono i lavori.
Nel 2011, la nuova giunta comunale spiegò che fermare completamente il progetto era ormai impossibile, i contratti erano stati firmati, una parte dei lavori era già stata fatta, bloccando tutto si dovevano pagare penali elevatissime. Cosa fare?
Non so proprio cosa fare, ma al pensiero di un enorme cantiere in Sant’Ambrogio io sto male; e ogni volta che si alza qualcuno e spiega che non ci sono rischi a scavare sotto Sant’Ambrogio sto ancora più male. La cosa non è finita qui: è notizia di ieri che a Brescia (Lega, PDL, ex Msi) è stato approvato un piano simile, un enorme scavo sotto i luoghi storici della città; e a Firenze non so se il sindaco Renzi abbia bloccato il progetto del tram sotto il campanile di Giotto, e notizie simili ne arrivano un po’ dappertutto, sia sui monumenti e sulle chiese che su boschi e parchi e terreni agricoli. Intanto il dibattito ferve: non sulle nostre chiese e sul nostro paesaggio in pericolo, ma sulla costruzione delle moschee. Mi sta anche bene che si possa discutere delle moschee, ma per carità, qui abbiamo millenni di Storia alle nostre spalle, qui si sta distruggendo la nostra memoria.
Qualche notizia storica però devo darla: la chiesa fu davvero edificata da sant’Ambrogio, intorno al 379-386 d.C. Il luogo scelto fu quello di un sacrario dedicato ai primi martiri cristiani, e infatti la chiesa è ancora dedicata a loro.Le prime modifiche furono fatte dal vescovo Angilberto, tra l’824 e l’860; l’assetto attuale risale al 1088-1099, vescovo Anselmo. Una chiesa costruita con materiali poveri, come spiegano le guide: mattoni, legno, pietre, cose che si potevano trovare anche nei dintorni; e la bellezza semplice e profonda dello stile romanico.
Per il resto, la storia di Sant’Ambrogio è lunga e piena di avvenimenti, non escluso il bombardamento della seconda guerra mondiale; ma per queste notizie è meglio andarsi a cercare un libro di Storia: è quello che sto per fare anch’io, di curiosità me ne sono venute molte e non si finisce mai di imparare, e di ricordare.
(le immagini vengono da www.wikipedia.it )
lunedì 19 marzo 2012
Milano via del Circo
Della Milano più antica, quella di epoca romana, è rimasto ben poco. Il posto più visibile e più frequentato è la zona delle colonne di San Lorenzo; ma in un’altra parte di Milano ci sono i resti del Circo, cioè di un’antica arena che non doveva essere molto differente da quella di Verona o dal Colosseo. L’idea di un’antica arena a Milano è molto suggestiva, ma i resti sono veramente poca cosa e spero che nessuno illuda i turisti raccontandone meraviglie; vale comunque la pena di farci un giro, anche perché si passa per alcune vie dove Milano è ancora Milano, il vero centro storico e non un posto qualsiasi dove si va solo per fare shopping. Il modo più semplice per arrivarci è probabilmente da corso Magenta, una delle vie storiche della città; la via da imboccare (andando a piedi, s’intende) è la via Bernardino Luini, che si chiama così perché costeggia San Maurizio, affrescata dal grande pittore lombardo (già che ci siamo, vale la pena di entrare e guardarsi in giro: Luini merita la visita, basterà dire che fino all’Ottocento neanche gli esperti riuscivano a capire quali quadri erano suoi e quali di Leonardo). In fondo alla via Luini ci sono delle vie che si chiamano via Cappuccio, via del Circo, via Brisa, i resti dell’antica arena sono lì, e il nome “via del Circo” parla chiaro.
Non c’è molto da vedere, come si diceva; anzi, a pensarci bene la cosa più importante da vedere è l’erba verde. Questo è forse l’unico posto di Milano dove ancora si può vedere l’erba; se si ha un po’ di pazienza magari spunta anche una lucertola, e non soltanto topi e scarafaggi come nel resto della città (detto per inciso, le lucertole mangiano gli scarafaggi, purché non siano troppo grossi – altrimenti, quando gli scarafaggi sono adulti, serve almeno un’iguana). Ma, sul pensiero dell’erba vista solo come sporcizia e come un impaccio da eliminare, divento davvero triste e preferisco sorvolare: fin da quand’ero bambino mi è sempre piaciuto girare fra i prati e i bordi delle strade, ma oggi è diventato impossibile farlo, e non soltanto a Milano. Negli ultimi trent’anni è infatti successo questo: che si sono visti con chiarezza tutti gli errori commessi a Milano, se ne è preso atto, e li si è trasportati e ampliati fino al confine con la Svizzera e in tutte le direzioni possibili, senza dimenticarsi nemmeno delle aiuole e dei vasi da fiore. E, di conseguenza, andate pure in via Circo: lì c’è qualcosa di ancora più raro dei resti romani, c’è un po’ di erba verde, finchè ce la lasciano.
Anche a Como, la mia città natale, c’era un posto così: le antiche terme. Da un paio d’anni, ci hanno costruito sopra un autosilo: ovviamente, costosissimo e con prezzi da far spavento se siete costretti a lasciarci la macchina.
(una o due di queste foto sono probabilmente mie, ma non mi ricordo quali: nel caso deprecabile in cui si dovesse scoprire che per ipotesi fossero proprietà di qualcuno, le levo subito e vado una scappata a farne un paio di esattamente identiche, sperando che nel frattempo le rovine non si siano stufate di stare lì).
Non c’è molto da vedere, come si diceva; anzi, a pensarci bene la cosa più importante da vedere è l’erba verde. Questo è forse l’unico posto di Milano dove ancora si può vedere l’erba; se si ha un po’ di pazienza magari spunta anche una lucertola, e non soltanto topi e scarafaggi come nel resto della città (detto per inciso, le lucertole mangiano gli scarafaggi, purché non siano troppo grossi – altrimenti, quando gli scarafaggi sono adulti, serve almeno un’iguana). Ma, sul pensiero dell’erba vista solo come sporcizia e come un impaccio da eliminare, divento davvero triste e preferisco sorvolare: fin da quand’ero bambino mi è sempre piaciuto girare fra i prati e i bordi delle strade, ma oggi è diventato impossibile farlo, e non soltanto a Milano. Negli ultimi trent’anni è infatti successo questo: che si sono visti con chiarezza tutti gli errori commessi a Milano, se ne è preso atto, e li si è trasportati e ampliati fino al confine con la Svizzera e in tutte le direzioni possibili, senza dimenticarsi nemmeno delle aiuole e dei vasi da fiore. E, di conseguenza, andate pure in via Circo: lì c’è qualcosa di ancora più raro dei resti romani, c’è un po’ di erba verde, finchè ce la lasciano.
Anche a Como, la mia città natale, c’era un posto così: le antiche terme. Da un paio d’anni, ci hanno costruito sopra un autosilo: ovviamente, costosissimo e con prezzi da far spavento se siete costretti a lasciarci la macchina.
(una o due di queste foto sono probabilmente mie, ma non mi ricordo quali: nel caso deprecabile in cui si dovesse scoprire che per ipotesi fossero proprietà di qualcuno, le levo subito e vado una scappata a farne un paio di esattamente identiche, sperando che nel frattempo le rovine non si siano stufate di stare lì).
sabato 17 marzo 2012
Il Duomo di Milano
Il recente restauro della facciata del Duomo è stata una delle più belle sorprese di questi ultimi anni. La facciata era già stata ripulita e sistemata negli anni ’90, temevo (ed era una preoccupazione comune a molti) che si trattasse di soldi e tempo sprecati, invece non è stato così: il risultato è sotto gli occhi di tutti. Non sono un esperto di restauro, ovviamente; sono solo un passante come tanti, ma mi sono reso conto del grande lavoro fatto, in tutti e due i restauri, guardando in tv (su Rai Storia, canale 54 digitale terrestre) due film molto belli che avevano proprio il Duomo come protagonista. Si tratta di “L’Italia vista dal cielo” di Folco Quilici (1970) e del documentario di Ermanno Olmi su Milano dalla serie “Le capitali della cultura” (1982): il Duomo era davvero sporco, e quella roba lì l’abbiamo respirata per anni. Ho anch’io il ricordo di pomeriggi passati in centro a Milano, e dopo tre o quattro ore in quell’aria anche un gesto semplice come soffiarsi il naso poteva fare impressione: il fazzoletto aveva una netta impronta di nero.
Da allora, da trent’anni fa, sono cambiate alcune cose, in meglio e in peggio: i lombardi hanno cambiato quasi tutti l’automobile (a loro spese: anche con gli incentivi, la macchina nuova ce la siamo pagata di tasca nostra), molte caldaie sono passate dalla nafta al metano o al teleriscaldamento, e questo è il lato positivo. Il lato negativo è la speculazione edilizia spaventosa, che ha coperto di cemento e di asfalto non più solo la città di Milano, ma ogni luogo della pianura padana, da Pavia alla Svizzera, da Torino a Venezia. Insomma, un passo avanti e tre indietro: e i danni provocati all’ambiente negli ultimi dieci-dodici anni rimarranno per secoli alle generazioni future, non basterà un lavaggio della facciata per dare aria pulita a Milano e alla Lombardia.
Tornando al Duomo, oggi si può vedere il suo vero colore: che non è bianco sepolcrale, ma colorato in rosa tenue. E’ il colore del marmo di Candoglia, con il quale fu costruito il Duomo di Milano.
Candoglia è in Val d’Ossola, frazione del comune di Mergozzo; a Candoglia ci sono le cave di questa “pietra granitica, di colore bianco-rosa o grigio-rosa”, come spiegano i testi ufficiali. Avendo studiato un po’ di chimica, posso dire che il colore rosa o rosso nelle pietre e nella terra è quasi sempre dovuto alla presenza di Ferro: il colore degli ossidi del ferro, cioè della ruggine.
I marmi di Candoglia arrivavano a Milano attraverso le vie d’acqua: dal piccolo lago di Mergozzo passando poi sul Lago Maggiore, sul Ticino, e infine nei Navigli. I Navigli milanesi scorrono ancora oggi vicini al Duomo ma non si vedono più perché sono stati coperti negli anni ’30. A due passi dal Duomo, verso via Sforza, c’è via Laghetto; il nome di questa via penso che a questo punto sia facile da capire: era il punto d’arrivo delle chiatte che portavano il marmo per la costruzione del Duomo (il laghetto non c’è più, inutile cercarlo).
Un’altra curiosità è legata alla frase “mangiare a ufo”, che deriva da “ad usum fabricae operis”: le chiatte che arrivavano con il marmo di Candoglia erano esentate dalle tasse, e portavano ben visibile l’abbreviazione della frasetta che permetteva loro di non pagare dazio.
Devo dire però, a conclusione di questo breve racconto, che purtroppo entrare nel Duomo (così come in molte altre grandi chiese o cattedrali d’Italia) è diventato una cosa un po’ triste. Fuori ci sono i soldati che ti perquisiscono, e magari tocca fare la coda perché è arrivata una comitiva (e a questo punto io rinuncio a entrare); ed è ormai in dirittura d’arrivo un biglietto d’ingresso. Per ora, i cinque euro da pagare per entrare in chiesa sembrano essere riservati solo alle comitive; per il futuro si vedrà. Insomma, la burocrazia è ormai arrivata ovunque: capisco bene che ci siano delle ragioni per farlo, spero solo che questa storia non venga presentata come modernità e progresso, come spesso (purtroppo per noi tutti) succede sempre più spesso e in svariati campi, lavoro compreso.
PS: e spero che a nessuno venga mai in mente di vietare ai passanti di sedersi sugli scalini: sarebbe un’infamia, ma altrove è già stato fatto. Anche questa, una triste novità di questo inizio di millennio.
AGGIORNAMENTO 2013: non si può entrare dalle entrate laterali, come si era sempre fatto. Adesso il Duomo ha gli ingressi e le uscite, come gli ipermercati. (al peggio non c'è mai fine, le grandi menti sono sempre al lavoro e ci rovinano la vita un po' ogni giorno). (la giovine militaressa che me lo ha fatto notare la prima volta me lo ha detto come se fosse una cosa ovvia e naturale, come l'acqua che sgorga dal cielo quando piove: "Signore, questa è l'uscita!" detto con sorrisino cortese e comprensivo. Santo Cielo, e dunque per più di quarant'anni consecutivi io ero in errore, e nessuno me lo aveva mai fatto notare???)
(le immagini dei Navigli vengono da “L’albero degli zoccoli” di Ermanno Olmi, che però si riferisce al lato opposto rispetto a Candoglia, cioè da Bergamo verso Milano)
Da allora, da trent’anni fa, sono cambiate alcune cose, in meglio e in peggio: i lombardi hanno cambiato quasi tutti l’automobile (a loro spese: anche con gli incentivi, la macchina nuova ce la siamo pagata di tasca nostra), molte caldaie sono passate dalla nafta al metano o al teleriscaldamento, e questo è il lato positivo. Il lato negativo è la speculazione edilizia spaventosa, che ha coperto di cemento e di asfalto non più solo la città di Milano, ma ogni luogo della pianura padana, da Pavia alla Svizzera, da Torino a Venezia. Insomma, un passo avanti e tre indietro: e i danni provocati all’ambiente negli ultimi dieci-dodici anni rimarranno per secoli alle generazioni future, non basterà un lavaggio della facciata per dare aria pulita a Milano e alla Lombardia.
Tornando al Duomo, oggi si può vedere il suo vero colore: che non è bianco sepolcrale, ma colorato in rosa tenue. E’ il colore del marmo di Candoglia, con il quale fu costruito il Duomo di Milano.
Candoglia è in Val d’Ossola, frazione del comune di Mergozzo; a Candoglia ci sono le cave di questa “pietra granitica, di colore bianco-rosa o grigio-rosa”, come spiegano i testi ufficiali. Avendo studiato un po’ di chimica, posso dire che il colore rosa o rosso nelle pietre e nella terra è quasi sempre dovuto alla presenza di Ferro: il colore degli ossidi del ferro, cioè della ruggine.
I marmi di Candoglia arrivavano a Milano attraverso le vie d’acqua: dal piccolo lago di Mergozzo passando poi sul Lago Maggiore, sul Ticino, e infine nei Navigli. I Navigli milanesi scorrono ancora oggi vicini al Duomo ma non si vedono più perché sono stati coperti negli anni ’30. A due passi dal Duomo, verso via Sforza, c’è via Laghetto; il nome di questa via penso che a questo punto sia facile da capire: era il punto d’arrivo delle chiatte che portavano il marmo per la costruzione del Duomo (il laghetto non c’è più, inutile cercarlo).
Un’altra curiosità è legata alla frase “mangiare a ufo”, che deriva da “ad usum fabricae operis”: le chiatte che arrivavano con il marmo di Candoglia erano esentate dalle tasse, e portavano ben visibile l’abbreviazione della frasetta che permetteva loro di non pagare dazio.
Devo dire però, a conclusione di questo breve racconto, che purtroppo entrare nel Duomo (così come in molte altre grandi chiese o cattedrali d’Italia) è diventato una cosa un po’ triste. Fuori ci sono i soldati che ti perquisiscono, e magari tocca fare la coda perché è arrivata una comitiva (e a questo punto io rinuncio a entrare); ed è ormai in dirittura d’arrivo un biglietto d’ingresso. Per ora, i cinque euro da pagare per entrare in chiesa sembrano essere riservati solo alle comitive; per il futuro si vedrà. Insomma, la burocrazia è ormai arrivata ovunque: capisco bene che ci siano delle ragioni per farlo, spero solo che questa storia non venga presentata come modernità e progresso, come spesso (purtroppo per noi tutti) succede sempre più spesso e in svariati campi, lavoro compreso.
PS: e spero che a nessuno venga mai in mente di vietare ai passanti di sedersi sugli scalini: sarebbe un’infamia, ma altrove è già stato fatto. Anche questa, una triste novità di questo inizio di millennio.
AGGIORNAMENTO 2013: non si può entrare dalle entrate laterali, come si era sempre fatto. Adesso il Duomo ha gli ingressi e le uscite, come gli ipermercati. (al peggio non c'è mai fine, le grandi menti sono sempre al lavoro e ci rovinano la vita un po' ogni giorno). (la giovine militaressa che me lo ha fatto notare la prima volta me lo ha detto come se fosse una cosa ovvia e naturale, come l'acqua che sgorga dal cielo quando piove: "Signore, questa è l'uscita!" detto con sorrisino cortese e comprensivo. Santo Cielo, e dunque per più di quarant'anni consecutivi io ero in errore, e nessuno me lo aveva mai fatto notare???)
(le immagini dei Navigli vengono da “L’albero degli zoccoli” di Ermanno Olmi, che però si riferisce al lato opposto rispetto a Candoglia, cioè da Bergamo verso Milano)
giovedì 15 marzo 2012
Milano Palazzo Reale
A Milano, Palazzo Reale è di fianco al Duomo, sul lato opposto rispetto alla Galleria; è un edificio antico che ha avuto numerose ristrutturazioni nel corso dei secoli. Prendo qualche notizia da http://www.wikipedia.it/ , avvertendo però che la storia completa del Palazzo Reale è molto più lunga di quella che riporto qui, ed è anche molto interessante.
«Il Palazzo Reale di Milano, per molti secoli sede del governo della città di Milano, è oggi un importante centro culturale, sede di mostre ed esposizioni. (...) Legato a filo doppio con la storia della città, il palazzo reale ha origini antiche. Nasce con il nome di Palazzo del Broletto Vecchio ed è sede del governo della città durante il periodo dei comuni nel basso medioevo. Il palazzo diviene centro politico durante le signorie delle casate Torriani, Visconti e Sforza, assumendo il ruolo di Palazzo Ducale, cioè sede del Ducato di Milano. Successivamente alla costruzione del duomo, avvenne un importante intervento di ristrutturazione, sotto il governo di Francesco Sforza. Nella seconda metà del diciottesimo secolo, sotto il dominio degli Asburgo, il Palazzo Reale è luogo di fastosa vita di corte e vede importanti artisti ed architetti lavorare a trasformazioni ispirate al barocchetto teresiano. (...) Ferdinando d'Asburgo-Lorena, uno dei figli di Maria Teresa, il 15 ottobre 1771, sposò nel duomo di Milano Maria Beatrice d'Este, divenendo in seguito il nuovo governatore della Lombardia austriaca, col dovere quindi di prendere residenza stabile a Palazzo Reale (...). L'idea iniziale di Ferdinando era quella di costruire un nuovo palazzo reale ove risiedere, lasciando il vecchio palazzo per l'accoglienza degli uffici di governo che andavano ampliandosi. Con questo intento egli si trasferì con la moglie a Palazzo Clerici nell'attesa dell'approvazione di un compromesso: il vecchio palazzo sarebbe stato quindi ristrutturato (...) I lavori iniziano ufficialmente nel 1773 sotto la direzione di Giuseppe Piermarini, affiancato da Leopold Pollack inviato da Vienna per controllare le spese e per diventarne l'allievo. (....) Esternamente, Piermarini diede un carattere sobrio ed austero alla costruzione, distaccandosi dal barocco ed inaugurando il neoclassico a Milano. (...) I lavori del Piermarini a palazzo si concluderanno ufficialmente il 17 giugno 1778, data in cui l'Arciduca Ferdinando lascerà Palazzo Clerici per andare ad abitare nel nuovo Palazzo Reale. Nel 1796 Napoleone Bonaparte, ancora generale, giunge a Milano conquistandola ed annettendola idealmente alla Francia con la costituzione della Repubblica Cisalpina. Il Palazzo Regio-Ducale, di conseguenza, prende il nome di Palazzo Nazionale e diviene sede dei principali organi di governo della nuova repubblica, e cioè il comando militare, prima e poi il Direttorio. Quando gli austro-russi riprenderanno il controllo del milanese nel 1799, il governo francese sarà frettolosamente costretto a vendere gran parte degli arredi del palazzo all'asta oltre a permettere il saccheggio di altre sale da parte della popolazione. Sarà solo nel 1805 che il palazzo tornerà a risorgere raggiungendo tra l'altro il suo picco massimo di splendore. Sarà infatti in quell'anno che Milano diverrà la capitale del neonato Regno d'Italia costituito da Napoleone per il figlio adottivo Eugenio di Beauharnais che viene nominato Viceré e prende residenza proprio nel Palazzo Reale di Milano. Milano è capitale di un vasto regno che comprende tutta l'Italia settentrionale e come tale anche la sede del nuovo governo necessita di essere all'altezza di questo privilegio. (...)»
L’ultimo restauro è molto recente; nel 2006, su un altro blog, avevo scritto un post che oggi mi fa piacere aggiornare.
Milano di marmo E’ finito il restauro esterno di Palazzo Reale, che ha cancellato il vecchio e ottocentesco colore giallo della facciata, così come era già stato fatto per la Scala un paio d’anni fa. Era il colore della vecchia Milano, della Milano di Verdi e della Cinque Giornate; i filologi dicono che è giusto così, che è la Milano neoclassica e settecentesca che torna a rivivere, e non ho motivo per dubitarne, anche perché io non sono un filologo. Ma anche questo è un segnale di come sta girando il mondo: un segno, più o meno inconscio, di restaurazione. Forse Milano non vuole più essere accogliente, e lo dimostra anche in questo modo: e magari sono io che esagero, ogni tanto mi capita. Ma io a quei colori risorgimentali ci ero affezionato, perché questi muri dipinti di giallo e di arancio sono stati la mia Milano, in tutti questi anni; una Milano diversa che forse non c’è mai stata, ma alla quale era bello pensare. Beh, pazienza: vuol dire che quando vorrò trovare qualcosa di caldo, a Milano, andrò a fare un giro al Monumentale.
(novembre 2006)
La novità è questa: passati sei anni, la facciata non è più così bianca e funerea. Non so se si tratti di naturale invecchiamento, oppure se sotto l’imbiancatura abbiano lasciato il colore: sta di fatto che un po’ di colore adesso c’è. Ho cominciato a notare il fatto un anno fa, e poi è arrivata la vittoria di Pisapia alle elezioni per il sindaco di Milano; ogni giorno che passa il fenomeno si accentua sempre di più, leggermente ma in maniera percettibile. Non riesco a pensare che i monumenti abbiano una loro vita e che possano manifestare una loro volontà, come accade in un bel racconto di Achille Campanile; ma se fosse vero sarebbe una bella cosa. Se ci si fa caso, anche il marmo del Duomo, lì di fronte, non è mica bianco funereo: è lievemente colorato, tendente al rosa, il colore naturale – stando a quello che ne dicono gli esperti - del marmo di Candoglia.
(almeno due di queste foto sono sicuramente mie, ma non so più quali; del resto, per mettere il copyright sulle foto fatte ai monumenti bisogna proprio essere un bel po’ gretti e tirchi, nel fondo dell’anima)
«Il Palazzo Reale di Milano, per molti secoli sede del governo della città di Milano, è oggi un importante centro culturale, sede di mostre ed esposizioni. (...) Legato a filo doppio con la storia della città, il palazzo reale ha origini antiche. Nasce con il nome di Palazzo del Broletto Vecchio ed è sede del governo della città durante il periodo dei comuni nel basso medioevo. Il palazzo diviene centro politico durante le signorie delle casate Torriani, Visconti e Sforza, assumendo il ruolo di Palazzo Ducale, cioè sede del Ducato di Milano. Successivamente alla costruzione del duomo, avvenne un importante intervento di ristrutturazione, sotto il governo di Francesco Sforza. Nella seconda metà del diciottesimo secolo, sotto il dominio degli Asburgo, il Palazzo Reale è luogo di fastosa vita di corte e vede importanti artisti ed architetti lavorare a trasformazioni ispirate al barocchetto teresiano. (...) Ferdinando d'Asburgo-Lorena, uno dei figli di Maria Teresa, il 15 ottobre 1771, sposò nel duomo di Milano Maria Beatrice d'Este, divenendo in seguito il nuovo governatore della Lombardia austriaca, col dovere quindi di prendere residenza stabile a Palazzo Reale (...). L'idea iniziale di Ferdinando era quella di costruire un nuovo palazzo reale ove risiedere, lasciando il vecchio palazzo per l'accoglienza degli uffici di governo che andavano ampliandosi. Con questo intento egli si trasferì con la moglie a Palazzo Clerici nell'attesa dell'approvazione di un compromesso: il vecchio palazzo sarebbe stato quindi ristrutturato (...) I lavori iniziano ufficialmente nel 1773 sotto la direzione di Giuseppe Piermarini, affiancato da Leopold Pollack inviato da Vienna per controllare le spese e per diventarne l'allievo. (....) Esternamente, Piermarini diede un carattere sobrio ed austero alla costruzione, distaccandosi dal barocco ed inaugurando il neoclassico a Milano. (...) I lavori del Piermarini a palazzo si concluderanno ufficialmente il 17 giugno 1778, data in cui l'Arciduca Ferdinando lascerà Palazzo Clerici per andare ad abitare nel nuovo Palazzo Reale. Nel 1796 Napoleone Bonaparte, ancora generale, giunge a Milano conquistandola ed annettendola idealmente alla Francia con la costituzione della Repubblica Cisalpina. Il Palazzo Regio-Ducale, di conseguenza, prende il nome di Palazzo Nazionale e diviene sede dei principali organi di governo della nuova repubblica, e cioè il comando militare, prima e poi il Direttorio. Quando gli austro-russi riprenderanno il controllo del milanese nel 1799, il governo francese sarà frettolosamente costretto a vendere gran parte degli arredi del palazzo all'asta oltre a permettere il saccheggio di altre sale da parte della popolazione. Sarà solo nel 1805 che il palazzo tornerà a risorgere raggiungendo tra l'altro il suo picco massimo di splendore. Sarà infatti in quell'anno che Milano diverrà la capitale del neonato Regno d'Italia costituito da Napoleone per il figlio adottivo Eugenio di Beauharnais che viene nominato Viceré e prende residenza proprio nel Palazzo Reale di Milano. Milano è capitale di un vasto regno che comprende tutta l'Italia settentrionale e come tale anche la sede del nuovo governo necessita di essere all'altezza di questo privilegio. (...)»
L’ultimo restauro è molto recente; nel 2006, su un altro blog, avevo scritto un post che oggi mi fa piacere aggiornare.
Milano di marmo E’ finito il restauro esterno di Palazzo Reale, che ha cancellato il vecchio e ottocentesco colore giallo della facciata, così come era già stato fatto per la Scala un paio d’anni fa. Era il colore della vecchia Milano, della Milano di Verdi e della Cinque Giornate; i filologi dicono che è giusto così, che è la Milano neoclassica e settecentesca che torna a rivivere, e non ho motivo per dubitarne, anche perché io non sono un filologo. Ma anche questo è un segnale di come sta girando il mondo: un segno, più o meno inconscio, di restaurazione. Forse Milano non vuole più essere accogliente, e lo dimostra anche in questo modo: e magari sono io che esagero, ogni tanto mi capita. Ma io a quei colori risorgimentali ci ero affezionato, perché questi muri dipinti di giallo e di arancio sono stati la mia Milano, in tutti questi anni; una Milano diversa che forse non c’è mai stata, ma alla quale era bello pensare. Beh, pazienza: vuol dire che quando vorrò trovare qualcosa di caldo, a Milano, andrò a fare un giro al Monumentale.
(novembre 2006)
La novità è questa: passati sei anni, la facciata non è più così bianca e funerea. Non so se si tratti di naturale invecchiamento, oppure se sotto l’imbiancatura abbiano lasciato il colore: sta di fatto che un po’ di colore adesso c’è. Ho cominciato a notare il fatto un anno fa, e poi è arrivata la vittoria di Pisapia alle elezioni per il sindaco di Milano; ogni giorno che passa il fenomeno si accentua sempre di più, leggermente ma in maniera percettibile. Non riesco a pensare che i monumenti abbiano una loro vita e che possano manifestare una loro volontà, come accade in un bel racconto di Achille Campanile; ma se fosse vero sarebbe una bella cosa. Se ci si fa caso, anche il marmo del Duomo, lì di fronte, non è mica bianco funereo: è lievemente colorato, tendente al rosa, il colore naturale – stando a quello che ne dicono gli esperti - del marmo di Candoglia.
(almeno due di queste foto sono sicuramente mie, ma non so più quali; del resto, per mettere il copyright sulle foto fatte ai monumenti bisogna proprio essere un bel po’ gretti e tirchi, nel fondo dell’anima)
lunedì 12 marzo 2012
Stazione di Piazza Cadorna
La Stazione di Piazza Cadorna è stata la mia porta su Milano, per questo la conosco bene. Era un luogo aperto e accogliente, come tutte le stazioni, ma poi qualcosa è successo.
Ne davo notizia così in un altro blog, il 24 maggio 2007:
Anche la mia stazione, quella di piazzale Cadorna delle Ferrovie Nord Milano, è cambiata. Hanno messo una grande barriera di cancelletti per timbrare. Prima non c’era niente, la stazione era un grande spazio aperto dove ognuno andava e veniva come meglio credeva; adesso c’è questa barriera diritta e meticolosa, anche un po’ minacciosa, così nessuno scapperà senza aver pagato il biglietto. Contemplo la linea Maginot, nuova di pacca e non ancora del tutto inaugurata; conto le minacciose obliteratrici e scopro che sono cinquanta. Mi chiedo chi avrà preso la mazzetta per tutte queste barriere, tra qui e la metropolitana dev’essere stato un bell’affare. Mi chiedo anche tante altre cose; soprattutto mi chiedo da dove provenga questo gran bisogno di mettere transenne, costruire muri, mettere tassametri, mettere macchine nuove e minacciose (per tecnologia e aspetto) un po’ ovunque, dalle Stazioni alle Poste. Forse è lo spirito del tempo: una volta qui al Nord si voleva costruire il muro al di là del Po, o magari al di qua, si discuteva se permettere l’accesso ai toscani e ai romani, o se anche gli emiliani dovessero essere considerati estranei; ma il più delle volte lo si diceva per scherzo. Adesso non se ne parla più ma i muri si fanno sul serio, e questo qui di piazza Cadorna è davvero un enorme muraglione d’acciaio. Ho letto proprio oggi sul giornale che perfino il Belgio rischia di rompersi, fiamminghi di qua e valloni di là. Ma qui per ora si tratta solo di pagare e timbrare il biglietto (beh, sì, per ora...)
Sono passati poco meno di cinque anni, sembra un’eternità; nel frattempo muraglie e obliteratrici sono spuntate ovunque. E’ un trend, come mi spiegarono una volta: ma ai trend ci si può anche opporre, non è che sia necessario andargli dietro come fanno i lemmings.
Provo a ragionarci sopra.
Le Ferrovie Nord Milano esistono da più di cent’anni, per la precisione dal 1887: si chiamano così perché servono le città a nord di Milano, Como e Varese, Novara. Adesso si stanno espandendo, e presto serviranno altre zone della Lombardia, il che è ovviamente un’ottima cosa. Ma non è che tutto vada bene, anzi: i nuovi treni sono brutti e scomodi, i finestrini troppo piccoli li fanno sembrano dei vagoni piombati, non c’è spazio per le valigie, i sedili sono piccoli e si viaggia costantemente con le nostre ginocchia tra le ginocchia degli altri, questi nuovi treni sembrano costruiti e progettati da gente che in treno non ha mai viaggiato. Anche le stazioni hanno subìto la stessa sorte: da luoghi aperti ed accoglienti sono diventati così come sono adesso. A voi piace? A me proprio no. Soprattutto, fa spavento vedere che hanno fatto sparire le sale d’attesa, che tutto è a pagamento, che sono sparite perfino le fontanelle d’acqua che erano utilissime per lavarsi le mani. Avete bisogno di lavarvi le mani? Bisogna pagare.
Porto qui alcune scene che erano molto comuni e che non si vedono più, a causa di queste modifiche: i ciechi e gli handicappati hanno vita durissima, prima potevano accedere ai treni da ogni parte, adesso sono costretti ad andarsi a cercare lo sportellino fatto apposta per loro; e in difficoltà siamo un po’ tutti, non solo gli anziani, perché non tutti i tornelli si aprono con il biglietto in mano: uno va lì e rimane come un fesso, non funziona? No, funziona: ma è l’ingresso riservato al biglietto elettronico. Ah, ecco. E dov’è dunque il mio ingresso? Intanto che cerco, magari il mio treno se ne va, perché – ma queste cose i nuovi dirigenti non le sanno – chi prende il treno va quasi sempre di corsa, anche un minuto è essenziale. Un’altra novità è che se perdi il treno, o se il treno arriva in ritardo, c’è una valanga di pubblicità ad attenderti sul binario – proprio sul binario, e vicino alle panchine, per carità, che non si possa sfuggire; e i biglietti e gli abbonamenti continuano a salire di prezzo, anche del 30% o più, ma la pubblicità è obbligatoria ovunque, ed è impossibile sottrarsi.
Un’altra scena molto comune, e che non si vedrà più, era questa: un ragazzo e una ragazza seduti dentro la carrozza, poi uno dei due si alza pochi istanti prima della partenza, scende, e il saluto continua dal finestrino. Quando accadeva, negli anni ’30? No, ieri: fino al 2007 era una cosa comunissima, con lui o lei a dire “adesso però scendi, se no il treno parte” e lei o lui a dire “ma no, c’è ancora tempo”. Dite che sono scemenze, smancerie? Non mi sembra proprio, è rendendo impossibili piccole cose come questa che si peggiora il mondo.
I nuovi dirigenti delle Ferrovie hanno dunque dichiarato guerra agli anziani, agli ipovedenti, agli handicappati (invece di abolire le barriere architettoniche, se ne costruiscono di nuove), e perfino agli innamorati e ai turisti stranieri che arrivano dalla Malpensa con due figli e due valigie, pensando di poterle caricare sul treno (ne ho già visti parecchi guardarsi in giro perplessi: dove si mettono le valigie? Signori, qui si viaggia sportivi, da manager, al massimo con la ventiquattrore o lo zainetto, non lo sapete?). Penso che non sia finita qui, con chi se la prenderanno in futuro è ancora da vedere, di certo non si fermeranno.
Conosco a memoria le obiezioni: la sicurezza, in primo luogo. Ma, se mi si permette, le Ferrovie esistono da più di cent’anni, le Nord dal 1887: questo significa essere passati non solo attraverso due guerre mondiali, ma anche attraverso le bombe neofasciste sui treni degli anni ’70, attraverso la bomba alla Stazione di Bologna del 1980, l’Italicus... Come è possibile che nessuno abbia mai avuto prima questa folgorante idea dei tornelli?
Un’altra obiezione solo apparentemente sensata è quella sui costi, sul deficit pubblico: il deficit pubblico negli anni ’50 e ’60 non c’era, e forse è necessario ripassare un po’ di storia recente. Il deficit statale che ci accompagna e ci preoccupa oggi comincia a nascere nel 1973, con la prima grande crisi petrolifera, l’inflazione a due cifre. Si può anche ricordare, ma non è essenziale, che le Ferrovie Nord erano in mano ai privati, che ci facevano affari: e questo fino al 1974, pagando il personale che era più numeroso con i contratti di quegli anni e le pensioni di quegli anni (gira e rigira, si va sempre a finire lì: licenziare, ridurre il personale, alzare i prezzi...). Anche qui, per più di cent’anni nessuno ha mai davvero pensato a mettere barriere e tornelli, le stazioni sono sempre rimaste luoghi aperti.
I nuovi dirigenti invece considerano prioritaria la spesa (una spesa mica da poco) per costruire barriere e tornelli, e per installare i teleschermi con la pubblicità: come hanno fatto le Ferrovie Nord, e le Ferrovie in generale, a sopravvivere per questi cent’anni, privi di cotanti manager?
Fossi un magistrato, o un giornalista, andrei ad indagare su chi costruisce obliteratrici e tornelli, e sulle società che gestiscono la pubblicità nelle stazioni, e anche la trasmissione continua di musica: quale musica, e a chi vanno i diritti d’autore. Vuoi vedere che salta fuori qualcosa di interessante?
(le fotografie sono mie, del maggio 2007: non c’è nessun copyright e le può prendere chi vuole e farne l’uso che preferisce)
AGGIORNAMENTO al 5 giugno 2012: et voilà, ecco che adesso bisogna timbrare anche per uscire. Mi domando cosa sarà la prossima, non oso pensarci. Mi hanno detto: "si fa così in tutta Europa", e io vorrei rispondere: "in tutta Europa tre quarti di CL sarebbe in galera o comunque fuori dalla politica", ma poi sorvolo perché so (purtroppo lo so) che sto parlando con dei precari. Fra due o tre settimane, comunque prima di settembre, nessuno di questi ragazzi sarà più qui a lavorare; il risparmio vero è infatti quello sul personale. Non credetegli, quando il Gran Capo Biesuz vi dice che ci sono tanti ma tanti che viaggiano senza biglietto: questi hanno già chiuso le biglietterie, adesso lasceranno a casa anche i controllori e i capitreno. (quelli come Biesuz e come Raffaele Cattaneo non rispondono mai alle domande: come mai in cent'anni di Stazione Cadorna non si era mai sentito il bisogno di mettere questa barriera? Ripeto: la Stazione Cadorna è stata aperta e senza barriere né tornelli per cent'anni, comprese quindi due Guerre Mondiali e le bombe nelle stazioni degli anni '70, mai e poi mai si era vista una cosa come questa).
AGGIORNAMENTO al 9 luglio 2012: la doppia timbratura, in entrata e in uscita, è stata estesa a tutte le stazioni del metrò. La burocrazia invade ogni piccolo spazio, siamo spiati e controllati ovunque, il prossimo passo - perché ci sarà un prossimo passo, non è certo finita qui - cosa può essere, la perquisizione? (con questi manager, la soluzione è sempre una e una sola: licenziare, ridurre il personale, rendere le nostre vite sempre più precarie. E così sarà anche stavolta.)
AGGIORNAMENTO all'ottobre 2018: la novità saranno le forche caudine, cioè una barriera in altezza per evitare che i più atletici saltino sui tornelli. Devo dire che li ho visti, e mi hanno ispirato una sanissima invidia perché nemmeno a vent'anni sapevo saltare così. Però io sono alto più del metro e ottanta di cui leggo, mi dovrò munire di casco? Nell'attesa di vedere cosa hanno inventato stavolta (e domani, e dopodomani? mamma mia...) regalo un soggetto agli sceneggiatori dei film: una giovane donna a cui rubano la borsetta, telefonino, smartphone (gli smartphone li rubano davvero), abbonamento del treno, bancomat di quelli nuovi che non serve più digitare il codice numerico e basta sfiorare il tornello per pagare, e siccome le stazioni sono ormai impresenziate ed è ormai buio (d'ottobre alle 18 è già buio) si ritrova senza la possibilità di prendere il treno, o la metropolitana, e senza nemmeno la apossibilità di telefonare a casa. Due alternative: girarlo in chiave horror (lo sconosciuto malintenzionato che la avvicina) o in chiave romantica (lo sconosciuto benintenzionato che la avvicina), sempre sperando che rimanga almeno un posto di polizia o dei carabinieri (o saranno anch'essi sostituiti da un tornello o da una colonnina digiti qui digiti là?)
Ne davo notizia così in un altro blog, il 24 maggio 2007:
Anche la mia stazione, quella di piazzale Cadorna delle Ferrovie Nord Milano, è cambiata. Hanno messo una grande barriera di cancelletti per timbrare. Prima non c’era niente, la stazione era un grande spazio aperto dove ognuno andava e veniva come meglio credeva; adesso c’è questa barriera diritta e meticolosa, anche un po’ minacciosa, così nessuno scapperà senza aver pagato il biglietto. Contemplo la linea Maginot, nuova di pacca e non ancora del tutto inaugurata; conto le minacciose obliteratrici e scopro che sono cinquanta. Mi chiedo chi avrà preso la mazzetta per tutte queste barriere, tra qui e la metropolitana dev’essere stato un bell’affare. Mi chiedo anche tante altre cose; soprattutto mi chiedo da dove provenga questo gran bisogno di mettere transenne, costruire muri, mettere tassametri, mettere macchine nuove e minacciose (per tecnologia e aspetto) un po’ ovunque, dalle Stazioni alle Poste. Forse è lo spirito del tempo: una volta qui al Nord si voleva costruire il muro al di là del Po, o magari al di qua, si discuteva se permettere l’accesso ai toscani e ai romani, o se anche gli emiliani dovessero essere considerati estranei; ma il più delle volte lo si diceva per scherzo. Adesso non se ne parla più ma i muri si fanno sul serio, e questo qui di piazza Cadorna è davvero un enorme muraglione d’acciaio. Ho letto proprio oggi sul giornale che perfino il Belgio rischia di rompersi, fiamminghi di qua e valloni di là. Ma qui per ora si tratta solo di pagare e timbrare il biglietto (beh, sì, per ora...)
Sono passati poco meno di cinque anni, sembra un’eternità; nel frattempo muraglie e obliteratrici sono spuntate ovunque. E’ un trend, come mi spiegarono una volta: ma ai trend ci si può anche opporre, non è che sia necessario andargli dietro come fanno i lemmings.
Provo a ragionarci sopra.
Le Ferrovie Nord Milano esistono da più di cent’anni, per la precisione dal 1887: si chiamano così perché servono le città a nord di Milano, Como e Varese, Novara. Adesso si stanno espandendo, e presto serviranno altre zone della Lombardia, il che è ovviamente un’ottima cosa. Ma non è che tutto vada bene, anzi: i nuovi treni sono brutti e scomodi, i finestrini troppo piccoli li fanno sembrano dei vagoni piombati, non c’è spazio per le valigie, i sedili sono piccoli e si viaggia costantemente con le nostre ginocchia tra le ginocchia degli altri, questi nuovi treni sembrano costruiti e progettati da gente che in treno non ha mai viaggiato. Anche le stazioni hanno subìto la stessa sorte: da luoghi aperti ed accoglienti sono diventati così come sono adesso. A voi piace? A me proprio no. Soprattutto, fa spavento vedere che hanno fatto sparire le sale d’attesa, che tutto è a pagamento, che sono sparite perfino le fontanelle d’acqua che erano utilissime per lavarsi le mani. Avete bisogno di lavarvi le mani? Bisogna pagare.
Porto qui alcune scene che erano molto comuni e che non si vedono più, a causa di queste modifiche: i ciechi e gli handicappati hanno vita durissima, prima potevano accedere ai treni da ogni parte, adesso sono costretti ad andarsi a cercare lo sportellino fatto apposta per loro; e in difficoltà siamo un po’ tutti, non solo gli anziani, perché non tutti i tornelli si aprono con il biglietto in mano: uno va lì e rimane come un fesso, non funziona? No, funziona: ma è l’ingresso riservato al biglietto elettronico. Ah, ecco. E dov’è dunque il mio ingresso? Intanto che cerco, magari il mio treno se ne va, perché – ma queste cose i nuovi dirigenti non le sanno – chi prende il treno va quasi sempre di corsa, anche un minuto è essenziale. Un’altra novità è che se perdi il treno, o se il treno arriva in ritardo, c’è una valanga di pubblicità ad attenderti sul binario – proprio sul binario, e vicino alle panchine, per carità, che non si possa sfuggire; e i biglietti e gli abbonamenti continuano a salire di prezzo, anche del 30% o più, ma la pubblicità è obbligatoria ovunque, ed è impossibile sottrarsi.
Un’altra scena molto comune, e che non si vedrà più, era questa: un ragazzo e una ragazza seduti dentro la carrozza, poi uno dei due si alza pochi istanti prima della partenza, scende, e il saluto continua dal finestrino. Quando accadeva, negli anni ’30? No, ieri: fino al 2007 era una cosa comunissima, con lui o lei a dire “adesso però scendi, se no il treno parte” e lei o lui a dire “ma no, c’è ancora tempo”. Dite che sono scemenze, smancerie? Non mi sembra proprio, è rendendo impossibili piccole cose come questa che si peggiora il mondo.
I nuovi dirigenti delle Ferrovie hanno dunque dichiarato guerra agli anziani, agli ipovedenti, agli handicappati (invece di abolire le barriere architettoniche, se ne costruiscono di nuove), e perfino agli innamorati e ai turisti stranieri che arrivano dalla Malpensa con due figli e due valigie, pensando di poterle caricare sul treno (ne ho già visti parecchi guardarsi in giro perplessi: dove si mettono le valigie? Signori, qui si viaggia sportivi, da manager, al massimo con la ventiquattrore o lo zainetto, non lo sapete?). Penso che non sia finita qui, con chi se la prenderanno in futuro è ancora da vedere, di certo non si fermeranno.
Conosco a memoria le obiezioni: la sicurezza, in primo luogo. Ma, se mi si permette, le Ferrovie esistono da più di cent’anni, le Nord dal 1887: questo significa essere passati non solo attraverso due guerre mondiali, ma anche attraverso le bombe neofasciste sui treni degli anni ’70, attraverso la bomba alla Stazione di Bologna del 1980, l’Italicus... Come è possibile che nessuno abbia mai avuto prima questa folgorante idea dei tornelli?
Un’altra obiezione solo apparentemente sensata è quella sui costi, sul deficit pubblico: il deficit pubblico negli anni ’50 e ’60 non c’era, e forse è necessario ripassare un po’ di storia recente. Il deficit statale che ci accompagna e ci preoccupa oggi comincia a nascere nel 1973, con la prima grande crisi petrolifera, l’inflazione a due cifre. Si può anche ricordare, ma non è essenziale, che le Ferrovie Nord erano in mano ai privati, che ci facevano affari: e questo fino al 1974, pagando il personale che era più numeroso con i contratti di quegli anni e le pensioni di quegli anni (gira e rigira, si va sempre a finire lì: licenziare, ridurre il personale, alzare i prezzi...). Anche qui, per più di cent’anni nessuno ha mai davvero pensato a mettere barriere e tornelli, le stazioni sono sempre rimaste luoghi aperti.
I nuovi dirigenti invece considerano prioritaria la spesa (una spesa mica da poco) per costruire barriere e tornelli, e per installare i teleschermi con la pubblicità: come hanno fatto le Ferrovie Nord, e le Ferrovie in generale, a sopravvivere per questi cent’anni, privi di cotanti manager?
Fossi un magistrato, o un giornalista, andrei ad indagare su chi costruisce obliteratrici e tornelli, e sulle società che gestiscono la pubblicità nelle stazioni, e anche la trasmissione continua di musica: quale musica, e a chi vanno i diritti d’autore. Vuoi vedere che salta fuori qualcosa di interessante?
(le fotografie sono mie, del maggio 2007: non c’è nessun copyright e le può prendere chi vuole e farne l’uso che preferisce)
AGGIORNAMENTO al 5 giugno 2012: et voilà, ecco che adesso bisogna timbrare anche per uscire. Mi domando cosa sarà la prossima, non oso pensarci. Mi hanno detto: "si fa così in tutta Europa", e io vorrei rispondere: "in tutta Europa tre quarti di CL sarebbe in galera o comunque fuori dalla politica", ma poi sorvolo perché so (purtroppo lo so) che sto parlando con dei precari. Fra due o tre settimane, comunque prima di settembre, nessuno di questi ragazzi sarà più qui a lavorare; il risparmio vero è infatti quello sul personale. Non credetegli, quando il Gran Capo Biesuz vi dice che ci sono tanti ma tanti che viaggiano senza biglietto: questi hanno già chiuso le biglietterie, adesso lasceranno a casa anche i controllori e i capitreno. (quelli come Biesuz e come Raffaele Cattaneo non rispondono mai alle domande: come mai in cent'anni di Stazione Cadorna non si era mai sentito il bisogno di mettere questa barriera? Ripeto: la Stazione Cadorna è stata aperta e senza barriere né tornelli per cent'anni, comprese quindi due Guerre Mondiali e le bombe nelle stazioni degli anni '70, mai e poi mai si era vista una cosa come questa).
AGGIORNAMENTO al 9 luglio 2012: la doppia timbratura, in entrata e in uscita, è stata estesa a tutte le stazioni del metrò. La burocrazia invade ogni piccolo spazio, siamo spiati e controllati ovunque, il prossimo passo - perché ci sarà un prossimo passo, non è certo finita qui - cosa può essere, la perquisizione? (con questi manager, la soluzione è sempre una e una sola: licenziare, ridurre il personale, rendere le nostre vite sempre più precarie. E così sarà anche stavolta.)
AGGIORNAMENTO all'ottobre 2018: la novità saranno le forche caudine, cioè una barriera in altezza per evitare che i più atletici saltino sui tornelli. Devo dire che li ho visti, e mi hanno ispirato una sanissima invidia perché nemmeno a vent'anni sapevo saltare così. Però io sono alto più del metro e ottanta di cui leggo, mi dovrò munire di casco? Nell'attesa di vedere cosa hanno inventato stavolta (e domani, e dopodomani? mamma mia...) regalo un soggetto agli sceneggiatori dei film: una giovane donna a cui rubano la borsetta, telefonino, smartphone (gli smartphone li rubano davvero), abbonamento del treno, bancomat di quelli nuovi che non serve più digitare il codice numerico e basta sfiorare il tornello per pagare, e siccome le stazioni sono ormai impresenziate ed è ormai buio (d'ottobre alle 18 è già buio) si ritrova senza la possibilità di prendere il treno, o la metropolitana, e senza nemmeno la apossibilità di telefonare a casa. Due alternative: girarlo in chiave horror (lo sconosciuto malintenzionato che la avvicina) o in chiave romantica (lo sconosciuto benintenzionato che la avvicina), sempre sperando che rimanga almeno un posto di polizia o dei carabinieri (o saranno anch'essi sostituiti da un tornello o da una colonnina digiti qui digiti là?)
domenica 11 marzo 2012
Piazza Cadorna
Ragionando sulla bruttezza di Milano, vera o presunta che sia, Piazza Cadorna rappresenta un caso disperato: è molto grande, e decisamente brutta. Nonostante la vicinanza del Castello Sforzesco e di Foro Bonaparte, piazza Cadorna rimane informe, anonima, brutta. Un caso disperato, per l’appunto.
Fino agli anni ’90, piazza Cadorna aveva comunque una sua bruttezza onesta: per metà era un grande parcheggio che serviva la stazione delle Ferrovie Nord, per l’altra metà un crocevia verso strade importanti, come corso Magenta: da piazza Cadorna, in un attimo, si arriva al Duomo, e anche al Cenacolo leonardesco, in Santa Maria delle Grazie. Anche andando a piedi, sono poco più di dieci minuti. In quel parcheggio, all’inizio degli anni ’90, ebbi perfino la sorpresa di ritrovare posteggiata la mia prima automobile: una Dyane 6 del 1971, che aveva ancora il sedile di guida come lo avevo risistemato io (cioè male).
Una decina di anni fa piazza Cadorna ha avuto un importante restyling, che l’ha resa ancora più brutta, con il mausoleo minoico di Gae Aulenti davanti alla Stazione, la solita e tristissima e onnipresente cascatella d’acqua sporca, le fontane di lamiera in stile spruzzo da campo di golf, e la scomparsa del parcheggio (che adesso è più lontano e si paga: è la novità obbligatoria di inizio millennio). Non che sia una cosa brutta in sè, il vero problema è che sembra una struttura pensata per un altro posto e riciclata qui. Dispiace vedere che dietro questo progetto ci sia il nome di Gae Aulenti, che altrove ha realizzato cose migliori, ma così è e sono costretto a prenderne atto. Il tempio minoico ideato dalla Aulenti avrebbe avuto senso in un altro posto, magari là dove sono state costruite stazioni nuove in vetro e cemento, ma qui siamo in mezzo a palazzi sette-ottocenteschi, Corso Magenta, Foro Bonaparte, il Parco Sempione, cosa c’entra questa struttura di metallo? Anche il colore non c’entra niente con quello che c’è intorno; e di questo penso che si siano accorti subito, visto che in seguito il palazzo della Stazione fu dipinto in verde affinché tutto nella piazza sembri perfettamente in stile. Il risultato è quello che è, ma so che a qualcuno piace e – soprattutto – so che la maggior parte della gente queste cose nemmeno le nota. Si può fare qualsiasi bruttura, nelle nostre strade e piazze: nessuno protesterà, e chi prova a dissentire si beccherà del matto e dell’incompetente.
Un moto di simpatia lo provo per il divertissement dell’olandese Claes Oldenburg, monumento all’ago e al filo, un enorme cavo di plastica colorato che ben pochi saprebbero identificare come ispirato all’alta moda milanese, e che molti scambiano per un tirante, guardandosi in giro a cercare quale mai struttura debba sostenere: forse la tettoia? Anche qui, però, vale la regola aurea di questo inizio di millennio: qualunque cosa si pensi sull’ago e filo di Oldenburg, la maggior parte della gente queste cose nemmeno si accorge che esistono.
C’è chi dice che la sfortuna di questa piazza si debba alla sua intitolazione: esistono infatti due Cadorna nella storia d’Italia, padre e figlio, due generali. Qui si tratta di Luigi (1850-1928, sostituito da Armando Diaz dopo Caporetto) e non di suo padre Raffaele (1815-97, eroe del Risorgimento, che entrò a Roma da Porta Pia): Luigi Cadorna è dunque il Cadorna sbagliato, ma cambiare i nomi di vie e piazze è sempre complicato e costoso, e d’altra parte, ormai, a questo punto...
PS: nello scrivere questo post ho usato due volte l’aggettivo “minoico”: si tratta del Palazzo di Cnosso, a Creta, quello del Labirinto e del Minotauro. Come si può notare, la somiglianza è notevole. (le foto le ho prese tempo fa su internet, forse un paio sono anche mie, chi se lo ricorda più - spero di non intoccare gli interessi di nessuno ripubblicandole qui, nel caso le sostituisco subito subito).
Fino agli anni ’90, piazza Cadorna aveva comunque una sua bruttezza onesta: per metà era un grande parcheggio che serviva la stazione delle Ferrovie Nord, per l’altra metà un crocevia verso strade importanti, come corso Magenta: da piazza Cadorna, in un attimo, si arriva al Duomo, e anche al Cenacolo leonardesco, in Santa Maria delle Grazie. Anche andando a piedi, sono poco più di dieci minuti. In quel parcheggio, all’inizio degli anni ’90, ebbi perfino la sorpresa di ritrovare posteggiata la mia prima automobile: una Dyane 6 del 1971, che aveva ancora il sedile di guida come lo avevo risistemato io (cioè male).
Una decina di anni fa piazza Cadorna ha avuto un importante restyling, che l’ha resa ancora più brutta, con il mausoleo minoico di Gae Aulenti davanti alla Stazione, la solita e tristissima e onnipresente cascatella d’acqua sporca, le fontane di lamiera in stile spruzzo da campo di golf, e la scomparsa del parcheggio (che adesso è più lontano e si paga: è la novità obbligatoria di inizio millennio). Non che sia una cosa brutta in sè, il vero problema è che sembra una struttura pensata per un altro posto e riciclata qui. Dispiace vedere che dietro questo progetto ci sia il nome di Gae Aulenti, che altrove ha realizzato cose migliori, ma così è e sono costretto a prenderne atto. Il tempio minoico ideato dalla Aulenti avrebbe avuto senso in un altro posto, magari là dove sono state costruite stazioni nuove in vetro e cemento, ma qui siamo in mezzo a palazzi sette-ottocenteschi, Corso Magenta, Foro Bonaparte, il Parco Sempione, cosa c’entra questa struttura di metallo? Anche il colore non c’entra niente con quello che c’è intorno; e di questo penso che si siano accorti subito, visto che in seguito il palazzo della Stazione fu dipinto in verde affinché tutto nella piazza sembri perfettamente in stile. Il risultato è quello che è, ma so che a qualcuno piace e – soprattutto – so che la maggior parte della gente queste cose nemmeno le nota. Si può fare qualsiasi bruttura, nelle nostre strade e piazze: nessuno protesterà, e chi prova a dissentire si beccherà del matto e dell’incompetente.
Un moto di simpatia lo provo per il divertissement dell’olandese Claes Oldenburg, monumento all’ago e al filo, un enorme cavo di plastica colorato che ben pochi saprebbero identificare come ispirato all’alta moda milanese, e che molti scambiano per un tirante, guardandosi in giro a cercare quale mai struttura debba sostenere: forse la tettoia? Anche qui, però, vale la regola aurea di questo inizio di millennio: qualunque cosa si pensi sull’ago e filo di Oldenburg, la maggior parte della gente queste cose nemmeno si accorge che esistono.
C’è chi dice che la sfortuna di questa piazza si debba alla sua intitolazione: esistono infatti due Cadorna nella storia d’Italia, padre e figlio, due generali. Qui si tratta di Luigi (1850-1928, sostituito da Armando Diaz dopo Caporetto) e non di suo padre Raffaele (1815-97, eroe del Risorgimento, che entrò a Roma da Porta Pia): Luigi Cadorna è dunque il Cadorna sbagliato, ma cambiare i nomi di vie e piazze è sempre complicato e costoso, e d’altra parte, ormai, a questo punto...
PS: nello scrivere questo post ho usato due volte l’aggettivo “minoico”: si tratta del Palazzo di Cnosso, a Creta, quello del Labirinto e del Minotauro. Come si può notare, la somiglianza è notevole. (le foto le ho prese tempo fa su internet, forse un paio sono anche mie, chi se lo ricorda più - spero di non intoccare gli interessi di nessuno ripubblicandole qui, nel caso le sostituisco subito subito).
sabato 10 marzo 2012
Piazza San Babila
La basilica di san Bàbila è uno dei posti di Milano a cui sono più affezionato. Innanzitutto, è una chiesa molto bella; l’origine è antica, ma ha subìto molte trasformazioni nel corso dei secoli. E poi ho diversi ricordi nei dintorni, nel suo lato verso corso Monforte: ricordi piacevoli e anche abbastanza strani, che per oggi lascerò a riposare nella mia memoria. Mi piacciono anche i dipinti e i mosaici all’interno, che risalgono all’inizio del Novecento: trovo belli soprattutto quelli del ferrarese Mentessi, nelle pareti laterali.
Insomma, della chiesa in San Bàbila, e della colonna sormontata da un leone che le si trova davanti, non posso che parlare bene. I problemi mi sorgono dopo, quando esco dalla chiesa e le volto le spalle. Piazza San Bàbila, a parte la chiesa, è veramente uno dei posti più brutti di Milano.
La chiesetta in San Bàbila (ormai mi viene da chiamarla così, non più Basilica ma “chiesetta”) schiacciata dal marmo e dal cemento razionalista-futurista di inizio Novecento, finisce per sembrare un corpo estraneo. Viene perfino il sospetto che in quegli anni abbiano pensato di buttarla giù, so bene che i mattoni rossi e le forme tondeggianti e gentili del romanico danno ancora fastidio, cent’anni dopo Terragni; ma si sa che c’è gente che trova fastidiosa la vista dell’orizzonte, figuriamoci una chiesa in mattoni.
Pensando a Piazza San Babila, mi chiedo cosa possa pensare un estraneo vedendola per la prima volta: non necessariamente un marziano ma magari un coreano, un arabo, un nigeriano. Essendo del tutto all’oscuro della nostra storia, la prima cosa che salterà all’occhio è che la chiesa è molto più antica di tutto quello che la circonda; voltando le spalle alla chiesa, un egiziano potrà pensare che palazzoni così ci sono anche al Cairo, a Tunisi, ovunque. Ma un egiziano avrebbe comunque nozione di cos’è una chiesa, in qualche modo potrebbe raccapezzarsi; qualcun altro invece, magari uno dei nostri bambini, potrebbe pensare di essere finito a Disneyland o a Gardaland, una bizzarria architettonica (la chiesa) distrattamente dimenticata in mezzo al cemento e ai palazzoni.
Che Milano sia brutta, in paragone alle altre città antiche d’Italia, è un luogo comune molto radicato: brutta e grigia. Una volta ricordato che il grigio è il colore del cemento, e quindi del Novecento (la chiesa di San Bàbila è rossa, i palazzi ottocenteschi sono gialli o rosa antico), chi conosce Milano sa che non è così, che a Milano ci sono ancora molti luoghi belli; ma poi bisogna abbassare la testa e ammettere che sì, è vero, Milano poteva essere una bella città ma molti danni sono stati fatti, la maggior parte recenti e irrimediabili.
Ciò che avrebbe potuto essere Milano lo si vede, San Bàbila a parte, camminando nella zona verso la Rotonda del Besana, nelle zone delle antiche Università, verso l’Istituto dei Tumori, qua e là alla Bovisa: qualcosa è ancora rimasto. Nel resto della città, ad aver trionfato è il cemento fascista, futurista e razionalista, roba da palazzinari, costruzioni fatte in fretta, velocemente, unificate da un look cimiteriale di marmo e di cemento. Tutto questo è ben visibile in piazza San Babila. I portici non sono male, questo va detto, ma i portici non sono la piazza.
Piazza San Bàbila è stata ristrutturata almeno un paio di volte, da quando la conosco io: il risultato di questi continui “restyling” è sempre peggiore del precedente. Di questo peggioramento è testimone la vasca di lamiera che vorrebbe fare da fontana, al lato opposto della Basilica: l’arredo urbano che c’era prima era ugualmente brutto, visti i risultati forse era meglio non toccare niente e limitarsi alla messa in sicurezza della piazza; ma dietro a ogni restyling e rifacimento ormai sappiamo cosa trovare, e suppongo che anche questa vasca, di per sè innocente nella sua bruttezza, abbia dietro qualche storia da raccontare: non tanto a me o ai passanti, ma magari a qualche giudice istruttore.
Qualche notizia storica, e qualche immagine, che prendo da un libro in vendita dentro la Chiesa.
San Bàbila fu vescovo di Milano fino al 250 d.C., anno in cui morì. Per dare un’idea del periodo storico, si può ricordare che Sant’Ambrogio visse fra il 339 e il 397. La chiesa a lui dedicata ha una storia molto lunga, le prime notizie certe di un assetto simile all’attuale risalgono al 1099 e al 1140, e fu probabilmente costruita vicino a una delle porte della città, della quale porta si è però persa ogni memoria. Lo stile architettonico originale è il romanico lombardo; la facciata fu però rifatta nel Seicento, in stile neoclassico. L’assetto attuale, con il ripristino del romanico, si deve ai lavori effettuati a partire dal 1881 sotto la guida dell’architetto Cesa Bianchi, che dovette intervenire a restaurare la Basilica, chiamato dalla Curia, a causa di pericolose infiltrazioni di umidità. I lavori furono completati nel 1926; della facciata neoclassica esistono le fotografie.
La colonna con la scultura leonina fu collocata nel 1626, il suo significato è ancora oggetto di molte interpretazioni, delle quali la più probabile è un riferimento a Venezia: il nome completo è infatti “colonna di Porta Orientale”. I dipinti e i mosaici all’interno, risalenti all’epoca dell’ultimo restauro, sono opera di diversi artisti, tra i quali Giuseppe Bertini, Luigi Pogliaghi, Giuseppe Mentessi, Luigi Cavenaghi. Il battistero risale al 1937, architetto Alfonso Orombelli.
(notizie da “La Basilica di San Babila” di Adele Buratti Mazzotta e Alessandro Gandini, in vendita solo all’interno della Basilica) (mio riassunto, il libro è molto bello e ricco di immagini e di notizie)
Insomma, della chiesa in San Bàbila, e della colonna sormontata da un leone che le si trova davanti, non posso che parlare bene. I problemi mi sorgono dopo, quando esco dalla chiesa e le volto le spalle. Piazza San Bàbila, a parte la chiesa, è veramente uno dei posti più brutti di Milano.
La chiesetta in San Bàbila (ormai mi viene da chiamarla così, non più Basilica ma “chiesetta”) schiacciata dal marmo e dal cemento razionalista-futurista di inizio Novecento, finisce per sembrare un corpo estraneo. Viene perfino il sospetto che in quegli anni abbiano pensato di buttarla giù, so bene che i mattoni rossi e le forme tondeggianti e gentili del romanico danno ancora fastidio, cent’anni dopo Terragni; ma si sa che c’è gente che trova fastidiosa la vista dell’orizzonte, figuriamoci una chiesa in mattoni.
Pensando a Piazza San Babila, mi chiedo cosa possa pensare un estraneo vedendola per la prima volta: non necessariamente un marziano ma magari un coreano, un arabo, un nigeriano. Essendo del tutto all’oscuro della nostra storia, la prima cosa che salterà all’occhio è che la chiesa è molto più antica di tutto quello che la circonda; voltando le spalle alla chiesa, un egiziano potrà pensare che palazzoni così ci sono anche al Cairo, a Tunisi, ovunque. Ma un egiziano avrebbe comunque nozione di cos’è una chiesa, in qualche modo potrebbe raccapezzarsi; qualcun altro invece, magari uno dei nostri bambini, potrebbe pensare di essere finito a Disneyland o a Gardaland, una bizzarria architettonica (la chiesa) distrattamente dimenticata in mezzo al cemento e ai palazzoni.
Che Milano sia brutta, in paragone alle altre città antiche d’Italia, è un luogo comune molto radicato: brutta e grigia. Una volta ricordato che il grigio è il colore del cemento, e quindi del Novecento (la chiesa di San Bàbila è rossa, i palazzi ottocenteschi sono gialli o rosa antico), chi conosce Milano sa che non è così, che a Milano ci sono ancora molti luoghi belli; ma poi bisogna abbassare la testa e ammettere che sì, è vero, Milano poteva essere una bella città ma molti danni sono stati fatti, la maggior parte recenti e irrimediabili.
Ciò che avrebbe potuto essere Milano lo si vede, San Bàbila a parte, camminando nella zona verso la Rotonda del Besana, nelle zone delle antiche Università, verso l’Istituto dei Tumori, qua e là alla Bovisa: qualcosa è ancora rimasto. Nel resto della città, ad aver trionfato è il cemento fascista, futurista e razionalista, roba da palazzinari, costruzioni fatte in fretta, velocemente, unificate da un look cimiteriale di marmo e di cemento. Tutto questo è ben visibile in piazza San Babila. I portici non sono male, questo va detto, ma i portici non sono la piazza.
Piazza San Bàbila è stata ristrutturata almeno un paio di volte, da quando la conosco io: il risultato di questi continui “restyling” è sempre peggiore del precedente. Di questo peggioramento è testimone la vasca di lamiera che vorrebbe fare da fontana, al lato opposto della Basilica: l’arredo urbano che c’era prima era ugualmente brutto, visti i risultati forse era meglio non toccare niente e limitarsi alla messa in sicurezza della piazza; ma dietro a ogni restyling e rifacimento ormai sappiamo cosa trovare, e suppongo che anche questa vasca, di per sè innocente nella sua bruttezza, abbia dietro qualche storia da raccontare: non tanto a me o ai passanti, ma magari a qualche giudice istruttore.
Qualche notizia storica, e qualche immagine, che prendo da un libro in vendita dentro la Chiesa.
San Bàbila fu vescovo di Milano fino al 250 d.C., anno in cui morì. Per dare un’idea del periodo storico, si può ricordare che Sant’Ambrogio visse fra il 339 e il 397. La chiesa a lui dedicata ha una storia molto lunga, le prime notizie certe di un assetto simile all’attuale risalgono al 1099 e al 1140, e fu probabilmente costruita vicino a una delle porte della città, della quale porta si è però persa ogni memoria. Lo stile architettonico originale è il romanico lombardo; la facciata fu però rifatta nel Seicento, in stile neoclassico. L’assetto attuale, con il ripristino del romanico, si deve ai lavori effettuati a partire dal 1881 sotto la guida dell’architetto Cesa Bianchi, che dovette intervenire a restaurare la Basilica, chiamato dalla Curia, a causa di pericolose infiltrazioni di umidità. I lavori furono completati nel 1926; della facciata neoclassica esistono le fotografie.
La colonna con la scultura leonina fu collocata nel 1626, il suo significato è ancora oggetto di molte interpretazioni, delle quali la più probabile è un riferimento a Venezia: il nome completo è infatti “colonna di Porta Orientale”. I dipinti e i mosaici all’interno, risalenti all’epoca dell’ultimo restauro, sono opera di diversi artisti, tra i quali Giuseppe Bertini, Luigi Pogliaghi, Giuseppe Mentessi, Luigi Cavenaghi. Il battistero risale al 1937, architetto Alfonso Orombelli.
(notizie da “La Basilica di San Babila” di Adele Buratti Mazzotta e Alessandro Gandini, in vendita solo all’interno della Basilica) (mio riassunto, il libro è molto bello e ricco di immagini e di notizie)
Iscriviti a:
Post (Atom)





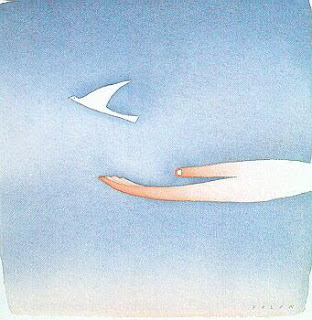
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)










.jpg)
